La dialettica
Sant'Agostino d'Ippona

Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
1. La dialettica è la scienza del disputare bene. E noi disputiamo sempre mediante le parole. Le parole sono semplici o congiunte. Sono semplici quelle che significano una cosa sola, come quando diciamo " uomo ", " cavallo ", " disputa ", " corre ". Non meravigliarti che " disputa ", nonostante sia composta di due elementi, sia inclusa tra le parole semplici: il motivo è chiarito dalla definizione. Si è detto che la parola semplice significa una cosa sola; ebbene, la parola " disputa " ricade sotto questa definizione, dalla quale invece è esclusa la parola " parlo " quando diciamo " parlo ". Quest'ultima infatti, benché sia una parola sola, tuttavia non ha un significato semplice, dal momento che significa anche la persona che parla. Pertanto, poiché può essere sia negata sia affermata, questa parola è ormai soggetta a verità o falsità. Dunque ogni prima ed ogni seconda persona del verbo, quant'anche siano enunciate separatamente, ciononostante devono essere annoverate tra le parole congiunte, perché non hanno un significato semplice: del resto, chiunque dica " cammino " fa in modo che con tale parola si intendano sia il camminare sia lui stesso che cammina, e chiunque dica " cammini " parimenti significa sia l'azione che è compiuta sia colui che la compie; invece, chi dice " cammina " non significa niente altro che il camminare stesso. Per questo ogni terza persona del verbo è sempre annoverata tra le parole semplici e non può essere né affermata né negata, a meno che non si tratti di verbi ai quali, nella consuetudine del parlare, sia unito necessariamente il significato della persona, come quando diciamo " piove " o " nevica ". È impossibile infatti annoverare tali verbi tra le parole semplici, perché si comprendono anche senza aggiungere " chi " compie l'azione del piovere o del nevicare.
2. Le parole congiunte sono quelle che, connesse tra loro, significano più cose, come quando diciamo " un uomo cammina " o " un uomo cammina affrettandosi verso il monte " e qualcosa di simile. Ma tra le parole congiunte ce ne sono alcune che formano una proposizione, come è il caso di quelle appena dette e altre invece che hanno bisogno di qualcosa perché la proposizione sia completa, come è il caso di quelle appena dette se si toglie da esse il verbo " cammina ". Sebbene, infatti, le parole " un uomo affrettandosi verso il monte " siano congiunte, tuttavia il discorso rimane ancora sospeso. Tralasciando dunque le parole congiunte che non danno luogo ad una proposizione completa, restano le parole congiunte che formano una proposizione. Anche di queste si danno due specie: o la proposizione è costituita in modo tale che la riteniamo soggetta al vero o al falso, come lo è " ogni uomo cammina " o " ogni uomo non cammina " e qualcosa di simile, oppure la proposizione è formata in modo tale che, per quanto attui ciò che la mente si è proposta, tuttavia non può essere né affermata né negata, come quando comandiamo, auguriamo, imprechiamo e cose simili. Infatti, a chiunque dica " va' alla villa " o " oh! se andasse alla villa " o " che gli dèi lo mandino in perdizione ", non è possibile dimostrargli che mente o credere che dica il vero, perché non ha né affermato né negato alcunché . Tali proposizioni perciò non si pongono neppure in discussione e non richiedono chi ne discuta.
3. Quelle invece che richiedono una discussione, sono semplici o congiunte. Sono semplici quelle che vengono enunciate senza essere connesse con altre proposizioni, come è il caso di quando diciamo " ogni uomo cammina "; mentre sono congiunte quelle sulla cui connessione si esprime un giudizio, come nel caso di " se cammina, si muove ". Ma quando si esprime un giudizio sulla congiunzione delle proposizioni, ci si dilunga molto fino a che non si perviene ad una conclusione, la quale peraltro non è che quella che si ottiene da quanto si è concesso. In altri termini, colui che dice " se cammina, si muove ", vuole provare qualche cosa di modo che, non appena gli avrò concesso che questo è vero, gli resta da mostrare che egli cammina; e da questo deriva la conclusione che ormai non è più possibile negare, che cioè egli si muove; oppure gli resta da mostrare che non si muove, di modo che ne segue la conclusione, parimenti impossibile da non ammettere, che cioè egli non cammina. D'altro canto, se egli intende dire così: " Quest'uomo cammina ", si tratta di una proposizione semplice; pertanto, se io l'avrò concessa ed egli ne avrà aggiunta un'altra del tipo " ma chiunque cammina, si muove ", ed io avrò concesso anche questa, da tale congiunzione di proposizioni, per quanto enunciate e concesse separatamente, segue quella conclusione che ormai è concessa inevitabilmente: " dunque quest'uomo si muove ".
4. Stabilite succintamente queste nozioni, consideriamo le singole parti. Si danno due prime parti: l'una relativa alle parole che si dicono in modo semplice, in cui è individuabile, per così dire, la materia della dialettica; l'altra relativa alle parole che si dicono congiunte, in cui ormai è visibile, per così dire, il suo prodotto. Quella che riguarda le parole semplici è chiamata la parte concernente il parlare, mentre quella che riguarda le parole congiunte si divide in tre parti. Tralasciando la congiunzione delle parole che non dà luogo ad una proposizione completa, quella parte che riguarda la congiunzione delle parole che dà luogo ad una proposizione completa in modo tuttavia da non suscitare ancora una questione o da richiedere uno che ne discuta, è chiamata la parte concernente l'esprimersi; invece quella parte che riguarda la congiunzione delle parole che dà luogo ad una proposizione così completa da esprimere un giudizio sulle proposizioni semplici, è chiamata la parte concernente l'enunciare; la parte infine che riguarda la congiunzione delle parole che dà luogo ad una proposizione così completa da esprimere un giudizio anche sulla stessa connessione delle proposizioni fino a che non si pervenga ad una conclusione, è chiamata la parte concernente la conclusione degli enunciati. Ma procediamo ora ad esporre le singole parti con maggiore precisione.
5. La parola è il segno di ciascuna cosa che, proferita da chi parla, può essere compresa da chi ascolta. Una cosa è tutto ciò che viene percepito o compreso oppure che resta sconosciuto. Un segno è ciò che manifesta se stesso ai sensi e qualcosa, oltre se stesso, alla mente. Parlare è dare un segno mediante la voce articolata. Chiamo articolata la voce che può essere espressa mediante lettere. Se tutto ciò che è stato definito, è stato definito correttamente, e se le parole fin qui impiegate per la definizione dovevano essere seguite da altre definizioni, lo renderà manifesto la sezione in cui si tratta della disciplina del definire. Ora fai attenzione a quello che sto per dire. Ogni parola ha un suono. Quando infatti essa è scritta, non è una parola, ma il segno di una parola; di certo, a chi legge, una volta che ha osservato le lettere, viene in mente ciò che fuoriesce attraverso la voce. Che altro infatti mostrano le lettere scritte, se non se stesse agli occhi e le voci, oltre se stesse, alla mente? E siccome poco fa abbiamo detto che il segno è ciò che manifesta se stesso ai sensi e qualcosa, oltre se stesso, alla mente, quelle che leggiamo dunque non sono parole, ma segni di parole. Ma come per la lettera, benché in se stessa sia la parte più piccola della voce articolata, tuttavia abusiamo chiamandola lettera anche quando la vediamo scritta - sebbene in questo caso sia assolutamente muta e non compaia come parte della voce ma come segno di una parte della voce -, così anche per la parola ne abusiamo chiamandola parola quando la troviamo scritta, quantunque si riveli segno di parola, cioè segno di voce significante e non parola. Dunque, come avevo cominciato a dire, ogni parola ha un suono. Ma ciò che ha un suono non ha nessuna attinenza con la dialettica. Infatti si ha a che fare con il suono della parola quando si domanda o si riconosce come il suono si addolcisca per una certa disposizione delle vocali o si apra per un loro incontro e, parimenti, come si aggrovigli per un'interposizione di consonanti o si inasprisca per una loro eccessiva concentrazione; inoltre, quando si domanda o si riconosce di quante o quali sillabe esso consti, oppure dove si trovino il ritmo poetico e l'accento: ebbene, in questi casi si tratta di questioni che riguardano il solo udito e di cui si occupano i grammatici. Pur tuttavia, quando si discute di queste cose, non lo si fa al di fuori della dialettica, perché questa è la scienza del disputare. Ma, poiché le parole sono segni delle cose quando da esse prendono valore, mentre sono segni delle parole quando sono quelle con cui si discute delle parole - infatti, non possiamo parlare delle parole se non mediante le parole e, inoltre, quando parliamo, non parliamo se non di cose - per la mente le parole sono segni delle cose, senza cessare di essere cose. Quando dunque la parola esce dalla bocca, se esce a motivo di se stessa, cioè per ricercare o discutere qualcosa intorno alla parola stessa, si dà di certo una cosa soggetta a discussione e ricerca, e questa cosa si chiama parola. Tutto ciò poi che della parola è percepito dalla mente e non dalle orecchie e che nella mente stessa è tenuto racchiuso, si chiama esprimibile (dicibile). Quando invece la parola esce dalla bocca non a motivo di se stessa, ma per significare qualcosa d'altro, si chiama espressione (dictio). La cosa stessa invece, che quindi non è né una parola né la parola concepita nella mente - che si dia o non si dia una parola mediante la quale possa essere significata - ormai non si chiama se non cosa, con nome appropriato. Si tengano distinte dunque queste quattro: la parola (verbum), l'esprimibile (dicibile), l'espressione (dictio), la cosa (res). Ciò che ho denominato " parola " è una parola e significa la parola; ciò che ho denominato " esprimibile " è una parola, che tuttavia non significa la parola, ma ciò che nella parola si comprende ed è contenuto nella mente; ciò che ho denominato " espressione " è una parola, tale però che significa contemporaneamente sia la parola stessa sia ciò che avviene nella mente mediante la parola; quella che ho denominato " cosa " è una parola che significa tutto ciò che resta, oltre alle tre di cui si è detto. Ma mi rendo conto che queste cose devono essere chiarite con esempi. Supponi dunque che un giovane sia interrogato da un grammatico in questo modo: " "Armi " , che parte del discorso è? ". Ciò che si è detto con " armi ", si è detto per se stesso, cioè la parola è stata proferita a motivo della parola stessa; mentre le restanti parole, per cui dice " che parte del discorso è ", sono state percepite dalla mente o proferite con la voce, non a motivo di se stesse, ma a motivo della parola " armi ". Ma quando sono state percepite dalla mente, prima di essere proferite, esse erano " esprimibili "; quando invece, per il motivo che ho detto, sono state proferite con la voce, sono diventate " espressione ". " Armi ", che in questo contesto è una parola, quando fu pronunciata da Virgilio, era una " espressione "; infatti, non fu proferita a motivo di se stessa, ma perché con essa fossero significate o le guerre sostenute da Enea o lo scudo o le altre armi fabbricate da Vulcano per l'eroe. Le guerre o armi, che invece furono combattute o portate da Enea - intendo dire le stesse che si vedevano quando erano combattute e c'erano, e che, se ora ci fossero, le potremmo indicare con il dito o toccare, e che, anche se non siano pensate, non per questo tuttavia significa che non ci siano state - quelle dunque per sé non sono né parole né " esprimibili " né " espressioni ", ma cose, che ormai sono chiamate tali con nome appropriato. In questa parte della dialettica dunque dobbiamo trattare delle parole, degli " esprimibili ", delle " espressioni ", delle cose . Anche se in tutte queste nozioni talora sono significate le parole e talora non lo sono, tuttavia non c'è nulla di cui non sia necessario disputare con le parole. Pertanto, in primo luogo si discuta delle parole mediante le quali è consentito disputare delle altre cose.
6. Ogni parola, dunque, al di fuori del suo suono - a proposito del quale disputare bene è di pertinenza dell'attività del dialettico e non della disciplina dialettica, così come avviene per le difese di Cicerone, le quali rientrano nella sua attività di retore, ma non sono lo strumento con cui s'insegna la retorica -, ogni parola dunque richiede in modo necessario che, oltre al suono, se ne discutano altri quattro aspetti: l'origine, la forza, la declinazione, la disposizione.
Si indaga sull'origine di una parola quando si ricerca per quale motivo si dica così come viene detta; a parer mio però, questa è un'indagine troppo minuziosa e non del tutto necessaria. E non mi piace dir questo perché anche Cicerone la pensa così ! Tra l'altro, poi, chi dovrebbe aver bisogno di una voce così autorevole per una questione tanto evidente? Inoltre, qualora giovasse veramente molto spiegare l'origine di una parola, sarebbe da sciocchi cominciare ciò che, per poter essere portato a termine, richiede certamente un impegno senza fine. Chi infatti potrebbe trovare il motivo per cui è stata detta in un certo modo una qualunque cosa che è stata detta? A questo si aggiunge che l'origine delle parole, come l'interpretazione dei sogni, è stabilita da ciascuno secondo la sua indole. Ecco uno che ritiene che le parole siano state dette verba dal fatto che, per così dire, percuotono l'orecchio; anzi, dice un altro, dal fatto che percuotono l'aria. Ma a noi che importa? Non è un grande contrasto, giacché entrambi fanno derivare l'origine di questo vocabolo da verberare. Ma guarda quale disputa provoca inopinatamente un terzo che afferma: " Poiché conviene che noi diciamo il vero ed è odioso, per giudizio della stessa natura, dire il falso, la parola è stata denominata verbum da verum ". E non è mancata una quarta idea ingegnosa: ci sono quelli che ritengono che la parola sia detta verbum da verum, ma che, una volta considerata a sufficienza la prima sillaba, non sia opportuno trascurare la seconda. Essi dicono infatti: " Quando diciamo verbum la prima sillaba significa " vero ", la seconda " suono " ", perché per costoro suono equivale a bum 1 (e infatti Ennio chiama bombum pedum lo strepitio dei piedi, i Greci chiamano ?????? il gridare e Virgilio reboant sylvae 2, rimbombano le selve). Quindi verbum è stato detto in qualche modo da verum boare, cioè dal far risuonare il vero. E, se è così, questo nome certamente prescrive di non mentire quando formuliamo una parola; ma temo che mentano proprio coloro che dicono queste cose. Quindi, spetta ormai a te giudicare se la parola è detta verbum da verberare o dal solo verum oppure da verum boare o se invece non curarci di sapere perché sia detta così, dal momento che capiamo che cosa essa significhi. Vorrei comunque che ti renda conto che, sia pur soltanto di passaggio, tuttavia ci siamo occupati del punto relativo all'origine delle parole perché non sembri che abbiamo trascurato qualche parte dell'opera intrapresa. Gli Stoici, che Cicerone in proposito irride come solo lui sa fare, sono del parere che non esista nessuna parola di cui sia impossibile spiegare l'origine in modo certo. E poiché sarebbe facile confutarli così, dicendo cioè loro che questo è un procedimento senza fine perché si dovrebbe ricercare anche l'origine delle parole con le quali si fosse spiegata l'origine di qualche parola, essi replicano che l'origine va ricercata fino a che non si perviene ad un punto tale che la cosa concordi, per qualche somiglianza, con il suono della parola, come quando diciamo tintinnio del bronzo, nitrito di cavalli, belato di pecore, squillo di trombe, stridore di catene. Vedi infatti che queste parole suonano come le cose stesse che esse significano. Ma poiché ci sono cose che non hanno suono, per queste dicono che vale la somiglianza basata sul tatto, così che, se giungono al tatto in modo lieve o aspro, la lievità o l'asprezza delle lettere genera il nome per le cose nello stesso modo in cui esso giunge all'udito, come quando diciamo lene (lievemente) che risuona lievemente. E, parimenti, chi non giudicherebbe aspra l'asperitas (asprezza) in base al nome stesso ? Per l'orecchio suona lieve quando diciamo voluptas (voluttà), aspro quando diciamo crux (croce) e le parole sono percepite così come le cose stesse impressionano. Si pensi a " miele ": il nome giunge all'udito tanto lievemente quanto gradevolmente la cosa stessa solletica il gusto. Acre è aspro sia per l'uno che per l'altro. Nel caso di lana (lana) e di vepres (spine) le parole sono udite così come tali cose sono percepite al tatto. Secondo l'opinione degli Stoici dunque, per così dire, la culla delle parole risiede dove le sensazioni delle cose concordano con la sensazione dei suoni. Da qui la libertà di imporre i nomi sarebbe proceduta fino alla somiglianza delle cose tra loro, di modo che, sebbene la croce sia detta crux a motivo della parola (dato che l'asprezza della stessa parola concorda con l'asprezza del dolore prodotto dalla croce), tuttavia le gambe sono chiamate crura non per l'asprezza del dolore ma perché, in fatto di lunghezza e durezza, rispetto alle altre membra sono più simili al legno della croce. Da qui si è passati all'abuso, al punto di usurpare il nome non di una cosa simile ma, per così dire, vicina. Che cosa hanno infatti di simile il significato di parvum (piccolo) e quello di minutum (diminuito), dal momento che può essere piccolo non solo ciò che non è per nulla diminuito, ma anche qualche cosa che sia cresciuto? Eppure, per una certa vicinanza, diciamo minutum per parvum. Ma questo abuso del vocabolo rientra nel potere di colui che parla: usa appunto parvum per non dire minutum. Per ciò che ora vogliamo mostrare è più pertinente quanto segue. Quando, in riferimento ai bagni si dice " piscina,", nonostante che questa non contenga pesci e nulla di simile ai pesci, sembra tuttavia che sia detta tale dai pesci, cioè a causa dell'acqua dove c'è la vita per i pesci. Così il vocabolo non è stato trasferito per somiglianza, ma usurpato per una certa vicinanza, di modo che, se qualcuno dicesse che gli uomini nuotando diventano simili ai pesci e che da qui è nato il nome di " piscina ", sarebbe da sciocchi opporvisi, poiché nessuna delle due ipotesi è incompatibile con la realtà ed entrambe restano oscure. Quanto detto dunque capita a proposito, perché questo solo esempio è sufficiente ormai per giudicare quale differenza ci sia tra l'origine della parola presa dalla vicinanza e l'origine della parola dedotta dalla somiglianza. Da qui si è avuta una progressione fino al caso contrario: lucus (bosco sacro) infatti si pensa che si chiami così perché vi risplende pochissimo la luce, bellum (guerra) perché non è una cosa bella, e foedus (alleanza) perché non è una cosa foeda (brutta). Che se poi foedus si chiami così dalla foeditas (bruttezza) del maiale, come parecchi vorrebbero, l'origine ritorna a quella vicinanza per cui ciò che accade prende il nome da ciò per cui accade. Una vicinanza di questo genere senza dubbio si estende ampiamente e si divide in molte specie: si dà in base alla capacità di produrre, come nel caso di foeditas (bruttezza) del maiale mediante la quale si dà foedus (alleanza); oppure in base a ciò che è prodotto, come avviene per puteus (pozzo), che si ritiene che di dica così perché il suo prodotto è la potatio (il bere); oppure in base a ciò da cui è contenuto, come urbs (città), che vogliono che si chiami così da orbis (il giro), perché, una volta presi gli auspici, si suole definire il luogo con un giro di aratro, della qual cosa vi è memoria anche in Virgilio dove " Enea delimita la città con l'aratro " 3; oppure in base a ciò che contiene, come se uno affermasse che horreum (il magazzino) è denominato così da hordeum (l'orzo), cambiata una lettera; o in base ad un abuso, come quando diciamo horreum e lì è riposto il triticum (il grano); o in base al fatto che si usa la parte per il tutto, come nel caso in cui chiamiamo la spada con il nome di mucro, che invece ne indica la punta; o in base al fatto che si usa il tutto per la parte, come avviene a proposito di capillus (il capello) impiegato come capitis pilus (il pelo del capo). A che scopo dovrei procedere oltre? Si può aggiungere qualsiasi altra cosa, ma tu vedrai che l'origine della parola risiede o nella somiglianza delle cose con i suoni o nella somiglianza delle cose tra loro o nella vicinanza o nel contrario. In verità non possiamo ricercare tale origine oltre la somiglianza del suono, e anche qui non sempre. Innumerevoli sono infatti le parole la cui origine, della quale si possa dar conto, o non esiste, come io credo, oppure rimane nascosta, come sostengono gli Stoici.
Guarda tuttavia un po' come pensano che si pervenga alla culla delle parole di cui si è parlato, o piuttosto alla radice o addirittura al seme, oltre il quale vietano di ricercare l'origine; e, d'altra parte, se qualcuno lo volesse fare, non riuscirebbe a trovare alcunché. Nessuno nega che le sillabe, tra le quali la lettera v occupa il posto di consonante - come lo è la prima lettera in parole del tipo vafer (scaltro), verum (vero), vinum (vino), vomis (vomere), vulnus (ferita) -, presentano un suono deciso e, per così dire, vigoroso. Questa è una cosa sulla quale concorda anche la consuetudine del parlare, poiché la toglie da alcune parole per non molestare l'udito. Non proviene infatti da qui che diciamo più volentieri amasti che amavisti (hai amato) e abiit che abivit (se ne andò) e innumerevoli altre parole simili? Dunque, quando diciamo vis (forza), il suono della parola, che, come si è detto, in un certo senso è vigoroso, si accorda con la cosa che essa significa. Ora, in base alla vicinanza di cui sopra, è possibile ritenere che vincula (i vincoli) siano così detti per l'effetto che producono, ossia per il fatto che esercitano violenza, che vimen (vimine) sia detto così per ciò con cui una cosa è legata (vinciri); e poi vites (le viti) siano dette così perché afferrano con intrecci i pali ai quali si appoggiano. Per questo, appunto, a motivo della somiglianza, Terenzio chiama vietus 4 (cadente) un vecchio ricurvo; per questo la terra, che appare tortuosa e battuta ai piedi di coloro che viaggiano, è detta via. Se però si crede che via sia detta così perché è battuta con la forza dei piedi, allora l'origine ritorna alla vicinanza di cui si è detto sopra. Supponiamo che sia detta così per la somiglianza con la vitis o con il vimen, cioè per la tortuosità; se dunque qualcuno mi chiede perché è detta via, io rispondo: per la tortuosità, perché gli antichi chiamavano vietus l'uomo che è piegato o ricurvo (per questo chiamano vieti anche i pezzi di legno delle ruote circondati dal cerchione). Se egli continua a chiedere perché ciò che è tortuoso si dica vietus, io rispondo: per la somiglianza con la vitis. Se insiste e pretende di sapere perché sia questo il nome della vite, io dico: perché lega (vincit) ciò che abbraccia. Se ricerca perché lo stesso legare (vincire) si dica così, noi rispondiamo: da vis (forza). Se poi chiedesse perché vis si chiami così, gliene sarà dato conto dicendo che la parola con il suo suono robusto e, per così dire, vigoroso si accorda con la cosa che significa. Non resta altro da ricercare. È da sciocchi invece aspirare a sapere in quanti modi l'origine delle parole si modifichi per l'alterazione dei suoni, perché è lungo e ancor meno necessario di quanto è stato detto fin qui.
7. Ora consideriamo brevemente, per quanto l'argomento lo consente, la forza delle parole. La forza di una parola è data da ciò mediante cui si conosce quanto vale ed essa vale tanto quanto può stimolare chi ascolta. Ora la parola stimola chi ascolta o per se stessa o per quello che significa o per l'uno e l'altro congiuntamente. Ma quando stimola per se stessa, è di pertinenza o del senso soltanto o dell'arte o di entrambi. Il senso è stimolato o secondo la natura o secondo la consuetudine. È stimolato secondo la natura, per esempio, quando prova una sensazione spiacevole se qualcuno nomina il re Artaxerxes, invece prova una sensazione piacevole se ode Euryalus 5. Chi infatti, pur non avendo mai udito nulla degli uomini che hanno questi nomi, tuttavia non giudicherebbe che nell'uno c'è la più grande asprezza e nell'altro levità? Il senso è stimolato secondo la consuetudine quando prova una sensazione sgradevole se qualcuno, per esempio, è chiamato Motta, e invece non la prova se ode Cotta. In questo caso, infatti, la gradevolezza o la sgradevolezza del suono non importano affatto, ma conta soltanto se la parte interna dell'udito riceve i suoni che la attraversano, per così dire, come ospiti noti o ignoti. Chi ascolta invece è stimolato secondo l'arte quando, una volta che gli è stata proposta una parola, considera di che parte del discorso si tratti oppure altro, se lo ha imparato nell'ambito delle discipline che insegnano intorno alle parole. Ma, in verità, si giudica della parola secondo il senso e l'arte, quando la ragione identifica ciò che è misurato dall'udito e gli impone un nome, come nel caso in cui si dice optimum (ottimo). Infatti non appena l'unica sillaba lunga e le due brevi di questo nome colpiscono l'orecchio, la mente vi riconosce subito, in base all'arte, un piede dattilo. Inoltre, la parola stimola non per se stessa ma per ciò che significa, quando la mente, ricevuto il segno mediante la parola, non guarda a niente altro che alla cosa stessa di cui quel segno è ciò che ha ricevuto, come quando, nominato Agostino, a colui a cui sono noto venga in mente soltanto io, mentre a colui che non mi conosce o che conosce un altro uomo di nome Agostino, qualora abbia udito questo nome, gli viene in mente qualsiasi uomo. Quando poi la parola stimola colui che la ode, ad un tempo per sé e per ciò che essa significa, allora la stessa enunciazione e ciò che da essa è enunciato sono percepiti insieme. Perché non viene urtata la castità dell'udito, quando ode " con la mano, col ventre, col pene aveva dissipato i beni paterni "? 6 Verrebbe urtata invece se quella parte vergognosa del corpo fosse chiamata con un nome ignobile e volgare, dal momento che è identica la cosa cui appartengono entrambi i vocaboli, ma con la differenza che nel primo caso la turpitudine della cosa significata è celata dal decoro della parola che la significa, mentre nel secondo la deformità di entrambe ferirebbe il senso e la mente. E così avviene a proposito della meretrice: non è infatti un'altra, tuttavia si presenta in un modo con l'abbigliamento con cui suole stare davanti al giudice, in un altro con l'abbigliamento con il quale suole giacere con un lussurioso nella camera da letto. Poiché dunque appare tanto grande e tanto varia la forza delle parole, che pure abbiamo trattato in breve, per quanto riguarda il tempo e, in modo sommario, ne scaturisce un duplice punto di vista secondo cui considerarla: l'uno per esporre la verità, che è di pertinenza del dialettico; l'altro per preservare il decoro, che è di pertinenza soprattutto dell'oratore. Sebbene infatti non sia opportuno che la disputa sia di scarso pregio e l'eloquenza menzognera, tuttavia, nell'una, spesso e, anzi, quasi sempre, la cupidigia di apprendere disprezza il piacere di ascoltare e, nell'altra, la moltitudine piuttosto inesperta ritiene che ciò che viene detto in modo elegante sia detto anche in modo veritiero. Poiché dunque è chiaro che cosa sia proprio di ciascuna, è evidente che anche colui che disputa, se ha qualche premura di dilettare, si deve aspergere di colore retorico e l'oratore, se vuole persuadere della verità, si deve irrobustire, per così dire, con i nervi e le ossa della dialettica; nervi e ossa che la natura stessa nei nostri corpi non ha potuto far mancare alla solidità del vigore fisico e non ha permesso che si manifestassero ad offesa degli occhi.
8. Pertanto ora, per discernere la verità, cosa che la dialettica promette di fare, vediamo quali impedimenti nascano da questa forza delle parole, di cui abbiamo detto qualcosa. Nelle parole sono l'ambiguità o l'oscurità ad impedire a chi ascolta di cogliere la verità. Tra l'ambiguità e l'oscurità c'è questa differenza: nell'ambiguità si mostrano più aspetti dei quali si ignora quale sia da preferire; nell'oscurità invece non appare niente o poco di ciò cui si presta attenzione. Ma quando è poco ciò che appare, l'oscurità è simile all'ambiguità: come se uno, iniziando un cammino, capitasse ad un bivio o ad un trivio o anche in un luogo, per così dire, dalle molte vie, dove però, per la densità della nebbia, nessuna via, che pure c'è, gli si manifesti; di conseguenza, in un primo momento, è l'oscurità che gli impedisce di proseguire; ma, non appena la nebbia ha cominciato a diradarsi un po', quel che si vede è incerto se sia la via o il colore tipico e ben nitido della terra: in questo consiste l'oscurità che è simile all'ambiguità. Rischiarandosi poi il cielo quanto è sufficiente per vedere, ormai appare chiara la distinzione tra le diverse vie; perciò, se si dubita per quale si debba proseguire, lo si fa non per l'oscurità ma per l'ambiguità. Allo stesso modo, si danno tre generi di oscurità. Il primo si ha quando una cosa è manifesta al senso ma nascosta alla mente; è questo il caso di uno che vedesse una melagrana dipinta senza averla mai vista e senza aver mai sentito dire di che genere di cosa si tratti: che egli non sappia di quale cosa quella sia la rappresentazione è questione che non riguarda gli occhi ma la mente. Il secondo genere si ha quando la cosa sarebbe manifesta alla mente, se non fosse nascosta al senso, come è il caso di un uomo dipinto quando si è al buio; non appena infatti sarà visibile, la mente non dubiterà affatto che si tratti di un uomo dipinto. Il terzo genere si ha quando rimane nascosto anche al senso ciò che, pur nell'eventualità in cui fosse svelato, tuttavia non si manifesterebbe affatto alla mente. Questo genere è il più oscuro di tutti: equivale al caso in cui uno, benché inesperto della melagrana, fosse costretto a riconoscerne una dipinta addirittura al buio.
Ritorna ora con la mente alle parole di cui queste sono similitudini. Immagina che un grammatico, riuniti i discepoli e imposto loro il silenzio, abbia detto con voce sommessa: temetum (vino puro). Ciò che è stato da lui detto, coloro che erano vicini lo hanno udito in modo sufficientemente chiaro, coloro che erano seduti un po' più lontano in modo poco chiaro, coloro invece che erano seduti molto lontano non sono stati sfiorati affatto da alcun suono. Tra i discepoli, poi, quelli che erano seduti vicino ignoravano che cosa fosse il temetum, mentre quelli che erano seduti più lontano, non so per quale caso, alcuni sapevano cosa esso fosse, altri lo ignoravano. Per quelli infine che non avevano recepito nemmeno la voce del maestro, rimaneva del tutto oscuro cosa fosse il temetum: erano tutti impediti dall'oscurità. Da questo esempio tu ormai comprendi tutti i generi di oscurità. Infatti, quelli che non nutrivano alcun dubbio a proposito di ciò che avevano udito erano soggetti al primo genere, cui è simile il caso della melagrana dipinta, ma esposta alla luce, per coloro che la ignoravano. Quelli che conoscevano la parola, ma che avevano udito la voce solo in parte o per niente affatto, soffrivano del secondo genere di oscurità, a cui è simile l'immagine dell'uomo posta in un luogo non visibile o completamente buio. Quelli invece che non erano esperti non solo della voce ma anche del significato della parola, erano avvolti nella cecità propria del terzo genere, che è la più brutta di tutte. Ciò che poi è stato detto, ovvero che una certa oscurità è simile all'ambiguità, si può riscontrare in coloro ai quali la parola era nota, ma non avevano percepito quasi nessuna voce o qualche voce, però non del tutto sicura. Eviterà dunque tutti i generi di oscurità del parlare chi farà uso di una voce alta quanto basta, di una pronuncia sciolta e di parole ben conosciute. Vedi ora, sempre nell'esempio del grammatico, quanto diversamente dall'oscurità sia di impedimento l'ambiguità della parola. Supponi che coloro che erano presenti abbiano recepito a sufficienza, mediante il senso, la voce del maestro e che costui abbia proferito una parola a tutti nota; immagina, per esempio, che abbia detto magnus e che poi sia restato in silenzio. Considera in quali incertezze essi si dibattano, una volta udito questo nome. Che cosa si dovrà rispondere, infatti, se egli chiederà " che parte del discorso è? "; che cosa se chiederà: " che piede è? ", in riferimento alla metrica?; che cosa, ancora, se farà domande di storia del tipo " quante guerre combatté il grande Pompeo? "; che cosa poi, se dirà: " grande e pressoché unico poeta è Virgilio ", per raccomandare delle poesie?; che cosa, infine, se uscisse fuori poi con queste parole: " Si è insinuata in voi una grande indolenza nei confronti dello studio della disciplina ", per riprovare la negligenza dei discepoli? Non vedi che, una volta dissipata la nebbia dell'oscurità, è emersa, come abbiamo detto sopra, una sorta di direzione dalle molte vie? Infatti, ciò che è stato detto magnus, benché sia uno solo, è un nome, è un piede trocheo, è Pompeo, è Virgilio, è l'indolenza della negligenza, e qualunque altra delle innumerevoli cose che non sono state ricordate e che tuttavia è possibile comprendere mediante l'enunciazione della parola.
9. Molto correttamente pertanto i dialettici dicono che ogni parola è ambigua. E non ci turbi che in Cicerone Ortensio li accusi falsamente così: " Affermano di cogliere le cose ambigue e di spiegarle lucidamente. Parimenti dicono che ogni parola è ambigua. Come dunque potranno spiegare le parole ambigue con parole ambigue? Questo infatti equivale a portare nelle tenebre un lume spento ". Tutto ciò in verità è detto in modo arguto e scaltro; ma questo è quello che, sempre in Cicerone, Scevola dice ad Antonio: " E infine come ai sapienti potrebbe sembrare che tu parli in modo eloquente, così agli stolti potrebbe sembrare che tu parli in modo veritiero ". E infatti che altro fa Ortensio in quel passo, se non spargere caligine sugli inesperti, con l'acutezza dell'ingegno e la gradevolezza del discorso, come con una bevanda pura e dolce? Ciò che infatti è detto, cioè che ogni parola è ambigua, è detto delle singole parole. Ma le parole ambigue vengono spiegate disputandone e nessuno di certo disputa con parole singole. Nessuno dunque spiegherà le parole ambigue con parole ambigue. E tuttavia, poiché ogni parola è ambigua, nessuno spiegherà l'ambiguità delle parole se non con parole, ma ormai con parole congiunte, che non saranno più parole ambigue. Come infatti, se dicessi " ogni soldato è bipede ", non ne seguirebbe che la coorte sia costituita tutta di soldati bipedi, così, quando dico che ogni parola è ambigua, non intendo dire né che lo sia la proposizione, né che lo sia la disputa, sebbene siano costituite di parole. Dunque, ogni parola ambigua sarà spiegata da una disputa non ambigua.
Vediamo ora i generi di ambiguità. Dei primi due, l'uno è quello che suscita il dubbio anche relativamente a ciò che viene detto, l'altro invece solo a proposito di ciò che viene scritto. Se infatti uno avrà udito acies (schiera) e se un altro l'avrà letto, potrà risultare incerto, a meno che non viene chiarito con una proposizione, se quanto detto o scritto riguarda l'acies dei soldati o l'acies (taglio affilato) della spada o l'acies (acutezza) degli occhi. Se invece uno trovasse scritto, per esempio, leporem e non gli appaia chiaro in quale proposizione sia stata posta, certamente dubiterà se la penultima sillaba di questa parola debba essere lunga (per derivazione da lepos) o breve (per derivazione da lepus). Naturalmente, non si dibatterebbe in questa perplessità se, dalla voce di chi parla, percepisse che si tratta del caso accusativo di questo nome. Che se poi qualcuno dicesse che chi parla potrebbe anche aver pronunciato male la parola, allora chi ascolta non sarebbe impedito dall'ambiguità ma dall'oscurità, di quel genere tuttavia che è simile all'ambiguità, perché una parola pronunciata male in latino non induce colui che vi riflette a diverse interpretazioni, ma lo spinge verso ciò che gli appare chiaro. Poiché dunque questi due generi sono tra loro molto differenti, il primo a sua volta si divide in due: infatti, qualunque cosa si dica può essere compresa mediante molte altre parole, e queste naturalmente possono essere contenute non soltanto in un solo vocabolo, ma anche in una sola definizione, oppure sono contenute soltanto in un vocabolo comune, ma chiarite mediante diverse spiegazioni. Quelle che si possono includere in una sola definizione sono denominate " univoche "; quelle invece che, pur comparendo sotto un solo nome, devono essere definite in modo diverso, sono denominate " equivoche ". Prima dunque consideriamo quelle univoche perché, come il genere cui appartengono è stato già reso manifesto tramite la definizione, così esse ora vengano illustrate con esempi. Quando diciamo " uomo ", diciamo tanto il ragazzo quanto il giovane e il vecchio, tanto lo stolto quanto il sapiente, tanto il grande quanto il piccolo, tanto il cittadino quanto il forestiero, tanto chi abita in città quanto chi abita in campagna, tanto chi è già stato quanto chi è ora, tanto chi sta seduto quanto chi sta in piedi, tanto il ricco quanto il povero, tanto chi fa qualcosa quanto chi sta in ozio, tanto chi gioisce quanto chi si addolora o non fa né l'una né l'altra cosa. Ma in tutte queste espressioni non c'è nulla che, come ha ricevuto il nome di uomo, allo stesso modo non sia incluso nella definizione di uomo. La definizione di uomo infatti è " animale mortale dotato di ragione ". Quindi, chi potrebbe dire che soltanto il giovane e non anche il ragazzo o il vecchio sia un animale mortale dotato di ragione, o che lo sia invece soltanto il sapiente e non anche lo stolto? Anzi, sia costoro sia tutti gli altri che sono stati menzionati, come sono inclusi nel nome di uomo, così sono inclusi anche nella definizione di uomo. Infatti, sia il ragazzo sia lo stolto sia il povero sia anche chi dorme, se non è animale mortale dotato di ragione, non è neppure un uomo; ma è un uomo, quindi è necessario che sia contenuto in quella definizione. Degli altri in verità nessuno dubita, ma del ragazzo piccolo o stolto, se non addirittura stupido, o di chi dorme o dell'ubriaco o di chi è infuriato si potrebbe dubitare di come possano essere animali dotati di ragione. Si potrebbe di certo dimostrare, ma sarebbe troppo dispendioso per noi che ci affrettiamo verso altre cose. Per ciò di cui qui si tratta è sufficiente dire che questa definizione di uomo non è corretta e valida, se non vi è contenuto ogni uomo e niente altro, oltre l'uomo. Sono dunque univoche le parole che non solo sono comprese in un solo nome, ma anche in una sola definizione del medesimo nome, sebbene si possano distinguere tra loro sia con propri nomi sia con proprie definizioni. Diversi, infatti, sono i nomi " ragazzo ", " adolescente ", " ricco " e " povero ", " libero " e " schiavo " e altre differenziazioni, se ve ne sono; tali nomi hanno pertanto proprie definizioni, diverse l'una dall'altra. Ma per essi, come l'unico nome comune è " uomo ", così anche l'unica definizione comune è " animale mortale dotato di ragione ".
10. Ora consideriamo le parole equivoche nelle quali prospera un groviglio quasi infinito di ambiguità. Tenterò tuttavia di distinguerle in generi ben determinati; se poi al mio tentativo si accompagna la capacità, sarai tu a giudicarlo. Innanzitutto, dunque, delle ambiguità che provengono dalle parole equivoche si danno tre generi: uno dall'arte, l'altro dalla consuetudine ed il terzo da entrambi. Dico arte, ora, a motivo dei nomi che sono imposti alle parole nelle discipline che riguardano le parole. I grammatici infatti definiscono in un modo che cosa sia il nome, in un altro che cosa sai il piede dattilo, in un altro ancora che cosa sia la parola equivoca. E tuttavia quest'unica parola che proferisco, Tullius (Tullio), è un nome, un piede dattilo e una parola equivoca. Pertanto, se uno mi chiedesse con insistenza di definire che cosa sia Tullius, devo rispondergli spiegandogli una qualsiasi di queste nozioni? Infatti posso correttamente dire: Tullius è un nome con il quale si significa un uomo, un sommo oratore che, come console, represse la congiura di Catilina. Ma non lasciarti sfuggire che ho definito il nome stesso; perché, se dovessi definire Tullio in persona, il quale, se fosse in vita, potrebbe essere indicato con il dito, non direi " Tullio è un nome con cui si significa un uomo ", ma direi " Tullio è un uomo " e poi aggiungerei il resto. Parimenti potrei rispondere così: " Tullio è un piede dattilo che consta di certe lettere ": che bisogno infatti c'è ora di enumerare tali lettere? Si potrebbe anche dire: " Tullio è la parola a motivo della quale sono tra loro equivoche tutte le cose, inclusa questa stessa, che sono state dette sopra e quante altre se ne potrebbero trovare ". Dal momento dunque che quest'unica parola da me proferita " Tullio " è stato possibile definirla in modo tanto vario, secondo la terminologia propria delle arti, perché dubitiamo del genere di parole ambigue che provengono dalle parole equivoche, genere che a buon diritto si può dire che si dia per via dell'arte? Abbiamo detto infatti che sono equivoche quelle parole che, mentre possono essere contenute in un solo nome, invece non possono essere contenute in una sola definizione. Considera ora un altro genere di parole equivoche che, come abbiamo ricordato, viene dalla consuetudine del parlare. Ora, chiamo consuetudine del parlare ciò stesso a motivo di cui conosciamo le parole. Chi infatti ricercherebbe e unirebbe insieme le parole a motivo delle parole? E così, supponi che uno ascolti in modo che non sappia affatto se la domanda riguarda le parti del discorso o i metri o qualche disciplina concernente le parole; egli peraltro, quando si dice " Tullio ", può essere ancora ostacolato dall'ambiguità delle parole equivoche, poiché con questo nome si può significare sia proprio colui che fu sommo oratore sia la sua immagine dipinta o la sua statua, sia il codice in cui sono contenuti i suoi scritti sia quello che c'è del suo cadavere nel sepolcro. Per questo, in base ai diversi aspetti diciamo sia " Tullio liberò la patria dalla rovina " sia " Tullio si erge in Campidoglio ricoperto di oro " sia " devi leggere Tullio tutto intero " sia " Tullio è sepolto in questo luogo ". Uno solo cioè è il nome, ma tutti questi usi vanno spiegati con differenti definizioni. Questo è dunque il genere di parole equivoche nel quale le ambiguità non nascono più dalla disciplina che riguarda le parole, ma dalle cose stesse che sono significate. Ma se entrambi i generi, sia quello relativo a ciò che è detto in base all'arte sia quello concernente ciò che è detto in base alla consuetudine, confondono chi ascolta e chi legge, non sarà bene aggiungerne un terzo? Un esempio di siffatto genere in verità appare già chiaramente all'interno di una proposizione, come nel caso in cui uno dicesse: " Molti hanno scritto in metro dattilico, come Tullio ". In questa proposizione, infatti, è incerto se " Tullio " è preso come esempio di piede dattilo o di poeta dattilico, ipotesi che sono desunte l'una dall'arte l'altra dalla consuetudine del parlare. Ma capita anche con le parole semplici, come nel caso in cui, come abbiamo mostrato sopra, il grammatico pronunci tale parola dinanzi ai discepoli che lo ascoltano.
Poiché dunque questi tre generi differiscono tra loro per ragioni evidenti, di nuovo il primo si divide in due. Tutto ciò che rende ambigue le parole a motivo dell'arte, in parte può essere di esempio per sé, in parte può non esserlo. Una volta infatti che ho definito che cosa significhi nomen (nome), posso presentare questa stessa parola come esempio: ciò che dico nomen è senz'altro un nome e infatti, quando diciamo " nomen, nominis, nomini ", esso, nei suoi casi, si declina secondo la regola dei nomi. Ugualmente, quando definisco che cosa significhi " piede dattilo ", si può prendere questo stesso come esempio, perché, quando diciamo dactylus (dattilo), pronunciamo una sola sillaba lunga e poi due brevi. Invece, quando si definisce che cosa significhi adverbium (avverbio), non si può prendere questa stessa parola come esempio, perché, quando diciamo adverbium, questa enunciazione è un nome. Così, per un aspetto è proprio un avverbio e non un nome, per un altro invece non è un avverbio perché è un nome. La stessa considerazione vale per il " piede cretico ": quando si definisce che cosa significhi, non può esser preso esso stesso come esempio; l'enunciazione, infatti, quando diciamo " cretico ", consta di una prima sillaba lunga e poi di due brevi, mentre ciò che significa è costituito di una sillaba lunga, di una breve e poi di una lunga. Così, anche in questo caso, per un aspetto il " cretico " non è altro che il " cretico " e non il dattilo, per un altro invece non è un cretico, perché è un dattilo.
Anche il secondo genere, che si è già detto di pertinenza della consuetudine del parlare, oltre che delle discipline concernenti le parole, ha due forme. Si tratta di parole equivoche che provengono o da una medesima origine o da una origine diversa. Ora, dico che provengono da una medesima origine quelle che, sebbene siano contenute in un solo nome ma non sotto una sola definizione, tuttavia scaturiscono come da una sola fonte, come è il caso di Tullius, che può essere inteso come l'uomo, come la statua, come il codice, come il cadavere. Codeste cose in verità non possono essere racchiuse in una sola definizione, tuttavia hanno una sola fonte, vale a dire lo stesso vero uomo, di cui è quella statua, quei libri e quel cadavere. Ma quando diciamo nepos (nipote) ci troviamo in tutt'altra situazione: per un'origine diversa significa figlio del figlio e dissoluto. Teniamo dunque distinti questi generi e osserva in quali generi a sua volta si divida quel genere che riguarda i nomi da me identificati in base alla medesima origine. Si divide infatti in due generi, dei quali uno si dà per traslato e l'altro per declinazione. Si dà per traslato nel caso in cui un unico nome diventa nome per molte cose o per somiglianza (come lo è " Tullio ", che è detto tale sia quello che fu un grande oratore sia la sua statua) o perché dal tutto si denomina una parte (come quando il suo cadavere è detto " Tullio ") o perché dalla parte si denomina il tutto (come quando chiamiamo " tetto " l'intera casa) o perché dal genere si denomina la specie (in via prioritaria infatti si dicono verba tutte le parole con cui parliamo; tuttavia sono denominate verba in senso proprio quelle che coniughiamo secondo i modi e i tempi) o perché dalla specie si denomina il genere (come avviene, per esempio, con gli " scolastici ": sono infatti così detti, non solo in senso proprio, ma anche in modo prioritario, quelli che sono ancora nelle scuole; tuttavia questo nome è usato impropriamente per tutti coloro che sono dediti alle lettere) o perché dalla causa si denomina l'effetto (come " Cicerone " che è il libro di Cicerone) o perché dall'effetto si denomina la causa (come " terrore " è chi suscita terrore) o perché dal contenitore si denomina ciò che è contenuto (come si dicono " la casa " anche coloro che sono in casa) o perché dal contenuto si denomina il contenitore (come " castagna " è detto anche l'albero) o perché da una medesima origine si denomina, come per trasferimento, qualsiasi altra cosa si possa trovare. Ti è chiaro ormai, come credo, che cosa produca l'ambiguità nelle parole. Queste sono invece le parole appartenenti ad una medesima origine, che abbiamo detto essere ambigue per la declinazione. Supponi, per esempio, che uno abbia detto pluit (piove o è piovuto): queste cose in ogni caso vanno definite in modo diverso. Parimenti, se uno dice scribere (scrivere o sii scritto), è incerto se lo abbia pronunciato all'infinito attivo o all'infinito passivo. E da homo (uomo), sebbene sia un solo nome ed una sola enunciazione, tuttavia si ha un risultato dal nominativo e un altro dal vocativo, come pure da doctus e docte, dove anche l'enunciazione è diversa. Doctius è una cosa quando diciamo doctius mancipium (uno schiavo più dotto), un'altra quando diciamo doctius illo iste disputavit (costui ha condotto la discussione in modo più dotto di lui). In questi casi dunque l'ambiguità sorge dalla declinazione. Ora, per declinatio (declinazione) intendo qualunque mutamento subiscano le parole sia relativamente al suono sia relativamente al significato, in seguito alla declinazione. Hic doctus e o docte appunto hanno subito una flessione anche nel suono, mentre hic homo e o homo solo nel significato. Ma sminuzzare questo genere di ambiguità e trattarlo in modo esaustivo è un'impresa pressoché infinita, pertanto sarà sufficiente aver considerato quest'argomento fin qui, soprattutto in rapporto alle tue capacità. Considera ora le parole equivoche che provengono da una diversa origine. Anche esse si dividono in due prime specie, una delle quali è quella che scaturisce dalla diversità delle lingue, come quando diciamo "tu ": quest'unica voce significa una cosa per i Greci, un'altra per noi. Di questo genere però si deve solo prendere nota; non è stato infatti prescritto a ciascuno quante lingue debba conoscere e in quante lingue debba essere in grado di disputare. La seconda forma è quella che dà luogo ad ambiguità in una sola lingua, ma con diversa origine delle cose che sono significate in un solo vocabolo, come lo è quanto abbiamo detto in precedenza per nepos. Questo genere a sua volta si divide in due: o cade sotto uno stesso genere di parte del discorso (nepos infatti è un nome sia quando significa figlio del figlio sia quando significa dissoluto) o sotto generi diversi (infatti non solo è diverso in qui da come è detto in qui scis ergo istuc nisi periculum feceris? 7 [come dunque fai a saperlo se non lo hai messo alla prova?]), ma, inoltre, nel primo caso è un pronome, nel secondo un avverbio.
Quindi da entrambe, cioè dall'arte e dalla consuetudine del parlare - che costituiscono il terzo genere a proposito dell'origine delle parole equivoche - possono provenire tante forme di ambiguità quante ne abbiamo enumerate nei due precedenti.
Resta ora quel genere di ambiguità che si riscontra solo negli scritti e di cui si danno tre specie; tale ambiguità infatti si dà o per la quantità delle sillabe o per l'accento o per entrambi i motivi. Si dà per la quantità, come quando si scrive venit (viene o venne) e si resta incerti relativamente al tempo, a causa della quantità non palese della prima sillaba. Si dà invece per l'accento, come quando si scrive pone (poni o dietro), dove, a causa della posizione non chiara dell'accento, si è nel dubbio se venga da pono o se sia da prendere nel senso in cui è detta nel verso pone sequens namque hanc dederat Proserpina legem 8 (alle spalle seguendolo, giacché questa era la norma imposta da Proserpina). Si dà anche per la quantità e per l'accento, come abbiamo detto in precedenza a proposito di lepore; infatti, la penultima sillaba di questa parola deve essere non solo allungata ma anche accentata, se è declinata da lepos e non da lepus.
 ITALIANO
ITALIANO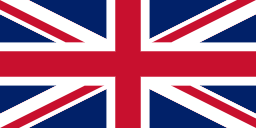 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL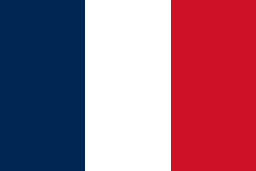 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ