Unione con Dio
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Nozione. E difficile precisare esattamente la portata di questa espressione che, tuttavia, è classica nel vocabolario della preghiera. In realtà, essa è legata ad un tema essenziale ad ogni antropologia religiosa, fin dal momento in cui questa si trova disarmata davanti alla molteplicità, sia esteriore che interiore, di un reale che sembra opporsi al desiderio che anima ogni uomo di un compimento ultimo. Costui, infatti, non può realizzarsi se non nell'unità, e il desiderio, nella sua realtà più profonda, si esprime allora in una formula del tipo " essere uno con l'Uno ". In verità, a proposito di una tale formula, si possono porre due domande, che segnano di fatto tutta la storia della mistica pagana, ma anche di quella cristiana. Cosa si può dire di quell'" Uno ", che sembra non avere nome (e non poterne ricevere, perché la molteplicità e la diversità delle parole è in principio contraria a ciò che è evocato con questa parola " Uno ")? E come si può concepire di essere " uno " con questo " Uno " senza perdere la propria identità? In altri termini, il desiderio dell'uomo lo porta ad una specie di fusione, che sarebbe sparizione, con o in ciò che è, per definizione, al di là di ogni nome, cioè l'Uno. La lotta contro la molteplicità non si risolverebbe mediante la scomparsa di ogni identità, sia quella dell'uomo che cerca, o quella dell'Uno che è cercato?
II. Nell'esperienza mistica. Nel cristianesimo, l'Uno ha un nome: lo si chiama " Dio " e lo si riconosce mediante la contemplazione del mistero di Gesù Cristo. Dio è colui che ha risuscitato Gesù dai morti per la potenza dello Spirito; è colui che, eternamente, genera il Figlio nella comunione dello Spirito. Ma è anche il Dio che ha creato il cielo e la terra e ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. La fede in Dio Trinità dà all'u. con Dio il carattere di una " comunione " poiché tale è anche la realtà intima di Dio. La fede in Dio Creatore, a sua volta, permette di escludere, non solo a un livello concettuale, ma anche a quello di un'esperienza spirituale, ogni idea di unità per fusione. Si potrebbe dire che la storia della mistica cristiana è, in un certo qual modo, quella della sua liberazione progressiva non del desiderio dell'u. con Dio, ma di quello di una perdita, stimata beatificante, di sé nell'Uno, mentre si tratta di una comunione trasfigurante in cui l'amore gioca tanto quanto la conoscenza.
Sarebbe interessante, per valutare le differenze tra le mistiche, portare avanti uno studio critico sull'uso comparato di enosis [termine non biblico] e di koinonia nei Padri della Chiesa. Non sarebbe impossibile che l'incontro contemporaneo con le mistiche orientali più elevate, interpretate con il tema d'unione con " l'Uno che non ha secondo ", provochi una nuova ripresa di questa storia; il compito, nel dialogo religioso, sarà allora riconoscere l'autenticità di una esperienza mistica, pur contestando l'eccesso di una pretesa unificatrice. Questo compito, che è sempre stato delicato, non lo sarà di meno oggi nella misura in cui, a testimonianza di mistici incontestabili, come s. Teresa, per esempio,1 l'impressione d'assorbimento in Dio è fortissima in certi stati mistici al punto che si ha la sensazione di mancare di strumenti concettuali per esprimere l'intensità smisurata di una comunione, senza cancellare tuttavia la distinzione tra Dio e l'uomo.
In realtà, quando, nel linguaggio corrente, si parla di unione con Dio, si indica forse qualcosa che dipende piuttosto da ciò che Lorenzo della Risurrezione chiamava: " Pratica della presenza di Dio " (la Bibbia greca ignora enosis, ma conosce, a più riprese, enopion!). Può trattarsi di uno sforzo senza violenza per " rimanere in presenza ", " essere con ", o negativamente, per non perdere un certo " sentimento " di relazione attuale: ma si può trattare anche di un dono che si potrebbe caratterizzare con una specie di " coscienza di presenza " che abita l'anima (nel senso in cui il latino parla di mens), mentre la ragione, teorica o pratica, e i sensi restano occupati nelle necessità dell'esistenza. E difficile analizzare le componenti della presenza di Dio, perché questa sfugge come definizione ad una concettualità troppo precisa. Si potrebbe soltanto insistere su due punti: perché ci sia " presenza ", cioè un esistere in relazione cosciente, occorre l'amore come liberazione di ogni chiusura su di sé o su un oggetto determinato e apertura, piacevolmente estatica, verso l'Altro: se non si ama, non c'è co-presenza, non c'è " unione " possibile; d'altra parte, occorre l'umiltà, come abbandono di sé alla misericordia di Colui che ama: nessuno può sentirsi degno di u. con Dio o capace di questa, perché il suo amore, giustamente, è troppo debole; l'umiltà colma la distanza nella misura in cui aspetta incessantemente da Dio il perdono per la debolezza di un amore e la generosità che, infine, vince ogni resistenza e ogni impotenza.
Note: 1 " L'anima è così fuori di sé da non pensare neppure alla differenza che la separa da Dio. Allora è l'amore che parla " (Vita, 34, 8). Da notare che Teresa non dice che non c'è differenza, ma che ella non la vede più.
Bibl. J. Castellano, s.v., in DES III, 2582-2588; M. Dupuy, s.v., in DSAM XVI, 40-62; M. Figura, Unio mystica, in WMy, 503-506; G. Philips, L'union personelle avec le Dieu vivant, Paris 1974; J. Trouillard, Uno (Filosofia dell'), in Aa.Vv., Enciclopedia Universalis, XVI, 461-463.
Autore: G. Lafont
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO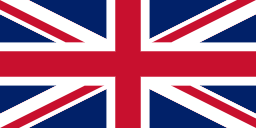 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL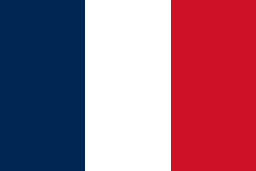 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ