Pauperismo
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Nozione. E l'impostazione di un'esistenza individuale o collettiva sulla base ispirazionale della povertà.
Propriamente il sostantivo p. allude all'idea o all'articolazione sistematica di idee (ridotte ed essenziali, in verità); povero individua la persona che subisce la povertà o quella che opta per essa, soprattutto per motivazioni ascetiche e mistiche; pauperistico designa un movimento o un gruppo che ispirano le proprie scelte comportamentali solitamente alla radicalità significata dalla rinuncia ai beni, dall'indifferenza per la propria indigenza, dalla mendicità.
L'innesto etimologico del p. sta nel sostantivo latino pauperies, meno utilizzato dell'equivalente e più versatile paupertas, e nell'aggettivo pauper. Oltre che povertà, quello significa mancanza di ricchezze, miseria, indigenza, ristrettezza, modestia, privazione. Il suffisso ismo è neologismo, inesistente nelle lingue classiche.
P. e pauperistico sono vocaboli non privi di valenze negative. Essi coinvolgono artificiosità comportamentali, scelte provvisorie estrose, contraddizioni nella dialettica tra ricchezza garantita e goduta e povertà appena verbalmente apprezzata, rifiuto aprioristico e irrazionale di benessere e progresso, disimpegnate teorizzazioni e simpatia verso una beatitudine della povertà scelta e favorita non per sé ma per altri, situazione sociale transitoria o permanente di economia bassa e insufficiente alla soddisfazione di umani bisogni.
II. L'itinerario della mistica è guidato dagli orientamenti della povertà piuttosto che da quelli del p. Tuttavia la spiritualità purifica da devianze e contiguità ambigue e negative del p. e ne recupera ispirazioni e prassi positive in ambito antropologico, psicologico, soteriologico-religioso. L'evangelo nobilita il p., ed è proprio nella prospettiva religiosa che il p. acquista senso e valore. La religiosità è manifestazione di una fede, segno del collegamento con il mondo del divino o almeno con una trascendenza che supera il terrestre e il contingente. In tale itinerario verso il mistero, la mistica è la tensione della ricerca, che si nutre anche di povertà.
Ogni religione si confronta con qualche risvolto del p. L'induismo evidenzia una grande e spontanea semplicità, inerme fiducia verso la miriade di divinità. Il buddhismo percorre la via del p. proteso alla eliminazione del desiderio, focolaio di dolore, fino alla spogliazione totale della persona ed impegna monaci e laici in una pur diversificata povertà. Il confucianesimo, refrattario alla mistica, tende a superare la povertà del mondo impegnando alla costruzione di benessere e felicità terrene.
L'ebraismo, a cominciare dalla Bibbia veterotestamentaria, situa nell'interiorità un suo tipico p., cioè quello di colui che è grato e gioioso dell'abbondanza dei beni, ma è pure consapevole di essere o è alla ricerca di diventare anawim, ossia povero, umile, fidente di fronte all'Onnipotente, perciò da lui benvoluto e avvolto di misericordia. L'islam assicura ricche ricompense al fedele, il muslin, ma al Misericordioso egli totalmente si abbandona come servo e bisognoso di aiuto.
Nell'itinerario della mistica, pertanto, il p. costituisce una traettoria maestra, ascesi indispensabile nella vivacità delle convinzioni e nelle evidenze coerenti della testimonianza.
III. P. e Vangelo. Il p. radica la propria ispirazione nell'Evangelo di Gesù Cristo; dirama le proprie ininterrotte propaggini lungo gli itinerari dell'ascesi verso la mistica, concretati soprattutto nella forma dell'eremitismo, del monachesimo, dei movimenti laici, degli Ordini mendicanti.
La qualità del p. cristiano si plasma e si motiva nello spirito delle beatitudini evangeliche. Esse cominciano con l'annuncio che sono beati i poveri in spirito (cf Mt 5,3), ossia coloro ai quali lo Spirito Santo fa capire la povertà. Tale povertà non è solo il distacco dallo stato del ricco, bersaglio dei " guai " evangelici (cf Lc 6,24), bensì è innesto a Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per arricchire i suoi con la propria povertà (cf 2 Cor 8,9). La ricchezza è un ostacolo alla sequela evangelica, ma può diventare tramite di misericordiosa condivisione con il povero (cf Mt 19,21-22, paralleli e contesti).
Siffatto "evangelo" di preferenza alla povertà è la piattaforma sulla quale si edifica la maggior parte delle tipologie della vita consacrata. Il voto di povertà è uno dei suoi capisaldi. La varietà delle forme testimoniali della povertà, quali la rinuncia e la condivisione dei beni, la solidarietà e il servizio ai poveri, rappresenta l'esteriorità di una opzione radicale, appunto il p. nella più sublime identificazione. Finalità della scelta pauperistica non è prioritariamente la povertà né fare atti di povertà, bensì farsi evangelicamente povero. Le elevazioni della mistica si raggiungono nell'interiorità dell'essere povero, anche se i gradini sono segnati da episodi di povertà. Tale itinerario e il medesimo approdo dell'essere povero interpellano ogni discepolo dell'evangelo, il seguace di Cristo d'ogni tempo. E itinerario attuale in ogni epoca.
IV. La storia della spiritualità documenta originalità e ripetitività nell'itinerario del p. L'egiziano Antonio, antesignano del monachesimo, imbocca la via della mistica vendendo i propri beni, donando il ricavato ai poveri, seguendo Cristo nell'anacoresi ovvero contemplazione eremitica, illuminato dalla Parola evangelica. Il monachesimo orientale ed occidentale, strutturato nella pluralità delle Regole, costituisce una tipologia di p. collettivo esternato nell'assenza di proprietà individuale (vivere sine proprio). Il rapporto con i beni della ricchezza è, però, solo un segno, seppure corposo: il monaco, colui che è alla ricerca di Dio e tende all'unità, da una parte si impoverisce per alleggerire il suo cammino ascetico, dall'altra nell'esperienza mistica in confronto con Dio si percepisce estremamente povero e totalmente bisognoso di lui.
La contraddizione tra povertà affettiva (interiore) ed effettiva (esteriore) ha consentito pingui accumuli di beni anche al monachesimo pauperistico: ed è stata una delle cause letali della sua decadenza. Il monachesimo rifiorisce anche riattivando la radice della povertà. I secc. XI-XIV sono i più esaltanti nella storia del p. cristiano. Il monachesimo rinnovato (da Cluny a Citeaux, da Camaldoli a Vallombrosa, dai monasteri doppi a quelli femminili abelardiani); gli Ordini mendicanti (francescani, domenicani, agostiniani, carmelitani, servi di Maria, altri soppressi); i movimenti laicali (valdesi, patarini, catari-albigesi e altri financo oltre il confine dell'ortodossia), o ritornano alla primitiva osservanza di povertà o aprono la loro esperienza sulle soglie dell'evangelo dove privilegiano la povertà portata sino alle opzioni più estreme, talune coraggiose e dignitose e tal'altre esagerate e illusorie. Anche la loro anima pauperistica è custodita nell'interiorità, oltre la vivace varietà delle forme: tale interiorità s'identifica con la humilitas, la minoritas, il servitium, l'essere pauperes propter Christum.
Quelle epoche movimentate da tali ispirazioni e istituzioni pauperistiche sono dense di contraddizioni per la presenza di pochi ricchi e potenti, tra i quali la gerarchia ecclesiastica, e la pullulazione di moltitudini di poveri e subalterni: un'epoca di negativo p. che si tenta di consolare con sublimazioni nel misticismo. I movimenti pauperistici con il richiamo evangelico alla povertà contestano quelle contraddizioni. Le istituzioni pauperistiche si incontrano lungo l'itinerario scolpito nel fortissimo imperativo e nella mistica esperienza del nudus nudum Christum sequire.
Il medesimo itinerario percorrono i mistici "classici", donne, grandi mistiche comprese. Emblematica è Maria di Oignies ( 1213): il biografo situa la motivazione della sua opzione pauperistica, spinta fino alla mendicità itinerante, nell'ut nudum Christum nuda sequeretur. Tale nuditas è il simbolo della spogliazione totale per seguire senza intralci il Signore e per meritare di potersi rivestire di Cristo.
Questo filone di p. spirituale attraversa le esperienze dei mistici successivi, e soprattutto delle mistiche, almeno fino al sec. XVII.
Le istituzioni dei religiosi, via via impiantate nella Chiesa, conservano il voto di povertà sebbene in maniera assai variegata ed attenuata. Il p., quale segno e mediazione mistica, appare velato soprattutto dall'enfasi delle diaconie e dalla imponenza delle strutture istituzionali.
V. La spiritualità odierna, dal Concilio Vaticano II in poi, motiva tutte le opzioni evangeliche con l'appartenenza di ogni battezzato all'unico indivisibile popolo di Dio, ossia alla Chiesa mistero e comunione.
Il linguaggio abituale schiva termini come p.: questa parola non si rinviene nei documenti conciliari e probabilmente nemmeno in altri del Magistero per indicare ispirazioni evangeliche supportate dalla povertà. Il vocabolo p. attualmente o serve a designare fenomeni preteriti o allude a circostanze soprattutto sociali connotate di negativo, pertanto temibili e scongiurabili. Il linguaggio della spiritualità e della mistica utilizza tuttora la parola p., ma con cautela e nelle inflessioni positive. Il sostantivo povertà e l'aggettivo sostantivato poveri sono con abbondanza ricorrenti.
La povertà evangelica è una sfida ultima dell'attualità. Il cerchio si chiude, il ciclo storico si riallaccia alle origini della Chiesa, allorchè i poveri erano evangelizzati ed erano beati i poveri nello Spirito Santo.
La Chiesa è guidata dal Cristo povero. La Chiesa è povera perché abitata da santi, ma anche da peccatori, cioè discepoli bisognosi della salvezza. La Chiesa è di tutti, soprattutto dei poveri e dei poveri fa l'opzione preferenziale. La Chiesa evangelizza i poveri, impegnata per la liberazione dei poveri. Anima della Chiesa è lo Spirito delle beatitudini, specialmente lo spirito della povertà che apre il regno di Dio. Maria, madre di Cristo e icona della Chiesa, primeggia tra i poveri del Signore.
Queste sono alcune coordinate sulle quali si intrecciano il p. odierno, l'esperienza della povertà evangelica quale eredità e impegno di tutto il popolo di Dio, la gerarchia e i presbiteri, i "consacrati" secondo le svariate tipologie, i laici nella pluralità di situazioni vocazionali. Si può qualificare la Chiesa come popolo dei poveri del Signore il cui spazio vitale è il p. evangelico.
L'atteggiamento pauperistico è viatico anche per l'attualità. E necessario attingere il distillato positivo di testimonianze ascetiche, esperienze mistiche, soluzioni istituzionali che hanno costellato i due millenni di storia del cristianesimo (ma anche prima e fuori di esso). Un ventaglio di efficacie sul terreno sociologico, antropologico-psicologico, ascetico e mistico giustifica e valorizza tuttora il p. oltre che la povertà evangelica.
Il p. conduce a equilibrio tra le esagerazioni: è la via del modesto tenore di vita che non equivale a mediocrità. Purifica da massimalismi plutocratici: possesso e ricchezza costituiscono assillo e turbamento che distraggono dalla spiritualità e squilibrano i rapporti interpersonali e sono guaribili ridimensionando le forze che spingono ad avere e possedere. Il p. contesta l'uso disinvolto ed esagerato del benessere: il benessere è un diritto, non una idolatria e l'uso equo lo fa bastare a ciascuno e responsabilizza per garantirlo a tutti. Il p. impegna a sollevare l'uomo dalla miseria: la povertà ingiusta e sciagurata è deformazione del p., situazione non appena argomento di studi antropologici o strategie economiche, bensì controparte d'una sfida di amore e giustizia. Il p. disvela il limite della persona umana. In assiomi di psicologia e antropologia la potenza dell'uomo è illimitata, ma nel realismo personale egli si scopre povero e circoscritto: l'accettazione del limite non è fatalismo nichilista o attendista, bensì umiltà. Il p. pacifica la consapevolezza di indegnità e bassezza umane di fronte alla sublimità di Dio: né esasperazione della miseria dell'uomo né sfida titanica a Dio placano quando può placare un'esperienza di povertà riempita nell'incontro mistico. Il p. percorre un itinerario penitenziale: il bisogno di conversione, ossia di miglioramento e di passaggio in spazi ottimali, è impulso innato nel cuore umano; è nostalgia non solo di abbandono del male e del peccato, ma ancor più della progressione verso promesse e sognate pienezze. Il p. postula tra le priorità l'ascesi. Nella realizzazione di sé il discepolo attraversa l'impoverimento lungo la via della rinuncia, della preghiera e della liturgia, della meditazione e della contemplazione: sono doni attesi dai poveri nello spirito. Il p. riconosce i doni che ogni persona alberga in sé: immagine e somiglianza di Dio, l'uomo e la donna sono scrigno dei doni divini: la consapevolezza di essi attiva gratitudine, gioia, agevolazione del loro dinamismo. Il p. è quieta attesa del dono dello Spirito Santo: " Il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono " (Lc 11,13). La beatitudine della povertà evangelica si completa nella invocazione e nell'accoglienza del dono massimo, lo Spirito Santo.
Bibl. Rarissimi sono i titoli sul pauperismo; imponente è la bibliografia sulla povertà: si citano taluni sussidi utili a intravedere ispirazioni e atteggiamenti connessi con un positivo evangelico pauperismo: Aa.Vv., Povertà, in DIP VII, 246-410; Aa.Vv., Pauvreté chrétienne, in DSAM XII1, 613-697; Aa.Vv., La pauvreté évangélique, Paris 1971; Aa.Vv., La povertà religiosa. Un approccio interdisciplinare, Bologna 1991; G.M. Colombas, El monacato primitivo, II, Madrid 1975; L. Dattrino, Il primo monachesimo, Roma 1984; L. De Candido, I mendicanti. Novità dello Spirito, Roma 1983; T. Goffi, Il povero, il primo dopo l'Unico, Brescia 1983; R. Grégoire, La vocazione sacerdotale. I canonici regolari nel Medioevo, Roma 1982; E. Peretto, Movimenti spirituali laicali del Medioevo. Tra ortodossia ed eresia, Roma 1985; A. Vanchez, Ordini mendicanti e società italiane nel XIII-XV secolo, Milano 1990.
Autore: L. De Candido
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO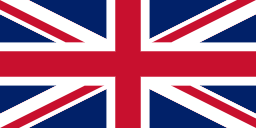 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL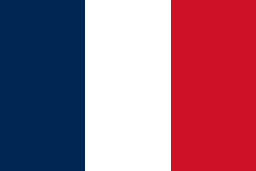 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ