Pacomio (santo)
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Vita e opere. Nasce nel nomo di Esneah (Tebaide superiore) da una famiglia pagana del sud dell'Egitto. Si converte alla vista della carità dei cristiani per le reclute imperiali. Si pone alla scuola dell'eremita Palamone ( 320 ca.) ma ben presto decide di organizzare un " villaggio cristiano ", cioè la vita comune di monaci disciplinati come un corpo unico. Molti lo seguono, perciò riunisce in vari monasteri, specialmente a Tabennesi e Pebow, migliaia di fratelli e anche suore. Poco prima della morte, avvenuta il 9 maggio 346 o, forse più precisamente (secondo le fonti copte) nella stessa data del 347, a causa di un'epidemia scoppiata tra i suoi monaci, è sottoposto al giudizio di un Sinodo di vescovi locali a Latopoli, ma l'energia dei suoi discepoli lo salva dalla condanna.
Fra questi, Teodoro ne conserva i ricordi più vivi che sono alla base delle Vite copte e della Vita prima in greco (redatta forse prima del testo copto). Le altre vite in greco e la vita in latino che ne dipendono si allontanano già dalla sicura autenticità dei documenti antichi.
Quanto alle Regole, è difficile sapere se siano state messe per iscritto prima della morte del fondatore. Nella traduzione di Girolamo esse si presentano in quattro collezioni non concordate. In copto ne sono stati trovati solo dei frammenti, in greco si hanno solo estratti.
P. è anche l'autore di lettere di linguaggio criptico, tradotte da Girolamo, scoperte recentemente in copto e in greco. Sono state, inoltre, scoperte alcune catechesi copte.
Le Vite fanno di P. un avversario di Origene; nondimeno sembra accertato che nella comunità fossero raccolti i libri " gnostici ", ritrovati a Nag Hammadi, che forse vi erano stati nascosti in occasione di qualche visita canonica.
II. Dottrina mistica. Nella storia della spiritualità cristiana P. è considerato il fondatore del tipo monastico di " vita comune " (koinos bios), che ha per ideale la comunità (koinonia) perfetta descritta in At 2,33 e 4,32. Essa comporta vari aspetti: a. l'unità nello spazio, chiuso con un recinto; il portiere che vi ammette ha anche la funzione quasi di un maestro dei novizi; b. la vita ordinata secondo una comune Regola, quindi uniforme; c. i membri di una grande famiglia spirituale portano un nome comune, la stessa veste e, tranne alcune eccezioni, vige la comunità della tavola e la uniformità dei cibi; d. comunità nella liturgia: i confratelli si riuniscono ogni giorno per una " colletta "; e. comunità nel lavoro; f. la vita è " comune " anche nel senso che è sopportabile da tutti, evita le eccezionali rigorosità dei solitari.
Pio laico, P. non ha una formazione teorica, ma possiede solide nozioni di teologia e di ascetica che gli provengono dalla Bibbia. Nelle sue Catechesi è ben presente la figura di Cristo " pastore delle pecore disperse ", che offre la sua vita in sacrificio. E proprio Cristo, Verbo eterno, che libera la discendenza di Eva dalla schiavitù del diavolo. La vita monastica offre al monaco, attraverso la preghiera, il digiuno, la veglia, l'umiltà, la carità mezzi validi per lottare contro il demonio e il peccato. Rispetto, quindi, all'ascetismo anacoretico, P. sottolinea soprattutto il valore interiore della rinuncia, realizzata nella koinonia, o nell'impegno della vita fraterna.
Uomo di Dio, P. è figura del monaco perfetto, del taumaturgo, del visionario, in breve, dell'uomo che attraverso una dura ascesi, praticata soprattutto nella vita fraterna, perviene alla mistica unione con Dio. Per questo motivo, a giusto titolo, i copti in due inni lo lodano come " aquila grande " (CSCO 107, 140, 142).
Più tardi, il suo ideale sarà ripreso da s. Basilio in Cappadocia e diverrà forma tradizionale del monachesimo della Chiesa.
Bibl. Opere: L.Th. Lefort, Les vies coptes de s. Pachôme, Louvain 1943, 1966; Id., Oeuvres de s. Pachôme et de ses disciples, CSCO 159-160, Louvain 1956; F. Moscatelli, Vita copta di S. Pacomio, Padova 1981; Pacomio e i suoi discepoli. Regole e scritti. Introd., trad. e note di L. Cremaschi, Magnano (BI) 1988. Studi: H. Bacht, s.v., in DSAM XII1, 7-15; Monachesimo e Chiesa. Studio sulla spiritualità di Pacomio, in J. Daniélou - M. Vorgrimler, Sentire ecclesiam. La coscienza della Chiesa come forza plasmatrice della pietà, Roma 1964, 193-224; M. Caprioli, s.v., in DES III, 1802-1805; J. Gribomont, s.v., in DIP VI, 1067-1073; R. Kurek, La meditazione della Bibbia presso i monaci pacomiani, in RivVitSp 37 (1983), 53-68; Id. Profilo della comunità pacomiana, in Ibid., 38 (1984), 274-297; V. Monachino, s.v., in EC IX, 511-514; A. Veilleux, s.v., in BS X, 9-20.
Autore: T. Spidlík
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO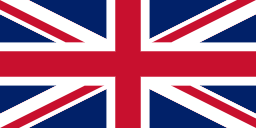 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL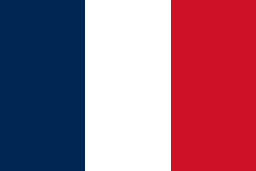 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ