Nevrosi
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Nozione. Gruppo di disturbi psichici caratterizzati da una sofferenza che si manifesta a livello di pensieri, sentimenti, comportamenti e fenomeni organici. I disturbi nevrotici per essere considerati tali debbono essere originati e mantenuti da fattori psicologici, debbono, pertanto, essere considerati come disturbi funzionali senza cioè un fondamento fisiologico evidente. Appartengono al gruppo delle n. (o "psiconevrosi", i termini sono equivalenti) manifestazioni o "sindromi" quali: l'isteria, le forme ossessivo-compulsive, le fobie, gli attacchi di panico e l'agorafobia, la depressione esogena e reattiva, la n. d'ansia o d'angoscia, l'ipocondria, la nevrastenia e le n. post-traumatiche da stress. A queste manifestazioni si deve aggiungere un altro tipo di n., non più psicogena ma di carattere spirituale, la cosiddetta n. noogena (V. Frankl). Anche se la persona affetta da n. può essere molto disturbata, nei casi più gravi vi può essere una marcata restrizione delle attività lavorative e sociali, in essa è sempre presente la consapevolezza della propria incapacità ad assumere comportamenti o stili di vita diversi: il sentirsi costretto a vivere in una determinata maniera. Nelle n., cioè, la persona non vive nella malattia, (come nelle psicosi, dove le idee deliranti trovano una percezione nel mondo reale), ma avverte la contraddizione fra ciò che sente e i dati che le provengono dalla realtà.
II. Cenni storici. Sebbene il termine n. fosse stato coniato nel 1777 dal neuropatologo scozzese W. Cullen per designare tutto un vasto gruppo di disturbi allora non del tutto spiegabili, le n. hanno accompagnato da sempre l'umanità, anche se si sono espresse in forme diverse dalle attuali. Ciò che è mutato nel corso dei secoli sono state le spiegazioni, le interpretazioni e le forme di cura.
Nelle culture primitive la spiegazione che veniva data alle manifestazioni nevrotiche, all'ansia e all'angoscia era quasi sempre di carattere magico: il disturbo veniva attribuito ad una forma di possessione magica o diabolica. Tale spiegazione ha continuato a prevalere anche in società più complesse, come quella babilonese, dove era curato con pratiche di carattere esorcistico-religioso. Nella civiltà greca prima e in quella romana poi, con il prevalere del pensiero razionale a discapito di quello magico-naturalistico, compare per la prima volta una spiegazione organicista delle malattie mentali in genere e delle n. in particolare. L'isteria e le altre forme nevrotiche non sono più causate da forze misteriose e magiche che si impossessano dell'individuo, ma da un danno organico che produce malattia. Con la decadenza della civiltà greco-romana c'è un riaffiorare del pensiero magico-irrazionale e la spiegazione dei comportamenti nevrotici torna ad essere magico-demonologica. Una tendenza questa che sarà presente per molti secoli. Alla fine del '400 due monaci tedeschi pubblicano il Malleus maleficarum (ll Martello delle streghe), un'opera scritta ad uso degli inquisitori, dove sono elencati i principali segni di stregoneria tra cui spicca l'isteria. Con l'Illuminismo la scienza inizia il suo cammino; ogni cosa del mondo naturale diventa oggetto di studio. La medicina diventa scienza e abbandona le interpretazioni magiche per muoversi alla ricerca delle cause naturali dei fenomeni. L'impostazione è fondamentalmente organicista. Agli inizi dell'800, la psichiatria è una disciplina prevalentemente a-psicologica che si interessa più di descrivere le sindromi che di comprenderle. Sebbene non ci sia un minimo dato scientifico che possa far ricollegare le n. a delle alterazioni cerebrali, non si mette in alcun dubbio che i disturbi del comportamento siano dovuti ad un'alterazione organica cerebrale.
Con il neurologo francese J.M. Charcot ( 1893) le n. divengono oggetto di studio sistematico ed escono dalle interpretazioni del modello medico-organicista. Le ricerche di Charcot furono riprese da Janet il quale evidenziò come alcune n. fossero originate da avvenimenti traumatici lontani negli anni dimenticati dalla persona. Le ricerche di Charcot e Janet aprirono la strada alla moderna concezione delle n. che, grazie soprattutto allo sforzo di Sigmund Freud, iniziarono ad essere studiate ed inquadrate sotto un profilo psicologico.
III. Principali teorie. Le Scuole del profondo. S'intendono tutte quelle scuole di psicoterapia che fanno risalire lo sviluppo delle n. a meccanismi psichici inconsci.
La prima, e per certi versi la più importante di queste scuole, è rappresentata dalla psicanalisi freudiana.
Il comportamentismo. La concezione delle n. è fortemente ispirata alle scoperte di I.P. Pavlov, di B.F. Skinner e altri secondo i quali il comportamento umano, sia nei suoi aspetti "normali" che in quelli "devianti", è determinato in primo luogo dall'ambiente e dagli stimoli che da esso provengono. Elemento base per lo sviluppo di una condotta è l'apprendimento. Così, secondo i comportamentisti, non esisterebbero differenze processuali fra normalità e n., in entrambi i casi ci si troverebbe di fronte a comportamenti che risultano da analoghi processi di apprendimento. Nei casi di n. i disturbi sono da ricondurre: a. sovrapprendimento (manifestazioni ossessive); b. apprendimento scorretto (ansia, attacchi di panico, agorafobia e fobie monosintomatiche); c. apprendimento assente o parziale (fobie sociali).
L'approccio cognitivo. La concezione delle n., per l'approccio cognitivo, è basata sulle acquisizioni della psicologia sperimentale, dell'etologia, della psicologia cognitiva e, per alcuni aspetti, sulle ricerche sul comportamento di attaccamento di J. Bowlby. Anche se conserva dei punti di contatto con il comportamentismo, l'approccio cognitivo assegna un ruolo fondamentale ai processi cognitivi ossia alle convinzioni relative a se stessi e al mondo. Queste cognizioni precedono e determinano sia le emozioni che il comportamento, tanto quello "normale" che quello patologico. Per i cognitivisti, dunque, il comportamento nevrotico non dipende unicamente dagli stimoli ambientali ma dalla rappresentazione, dalle opinioni che ognuno ha del suo ambiente. Ora, queste rappresentazioni e queste opinioni sarebbero il risultato di una complessa interazione tra le conoscenze innate e quelle apprese e gli stimoli ambientali.
La logoterapia e l'Analisi esistenziale. Secondo lo psichiatra viennese V. Frankl, una n. può anche essere la manifestazione a livello psicologico di un problema di carattere spirituale. In questi casi non si parla di n. psicogena, bensì di n. noogena. Frankl distingue, infatti, nell'essere umano tre dimensioni: la somatica, la psichica e la noetica. La noetica, o spirituale, è la dimensione dei valori e dei significati. Una n. noogena si manifesterebbe quando la volontà di significato non viene esaudita, quando cioè l'uomo non riesce a trovare un significato nella vita che la renda degna di essere vissuta. La n. noogena può anche essere l'effetto di un conflitto tra valori apparentemente simili. Anche se di natura spirituale, la n. noogena si presenta con tutte le caratteristiche di una n. psicogena.
G. Froggio
IV. Nella vita spirituale. Uno dei motivi per esporre nei dettagli il concetto di n. in questo contesto è quello di offrire la possibilità di comparare più di due interpretazioni che si possono dare a uno stesso comportamento. Per esempio nel 1800, la psicologia - che era ancora agli albori della scientificità nonostante le illusioni positiviste - interpretava alcuni comportamenti religiosi semplicemente come n. di massa e la religione come una n. ossessiva dell'umanità. Questo avveniva anche perché sembrava che ci fosse un solo modo d'intendere la n. e anche la religione era generalizzata per alcune sue forme esterne tipiche del puritanesimo protestante vittoriano e del dogmatismo cattolico romano di quell'epoca.
Anche in tempi più recenti, la poca chiarezza in materia di n. ha reso difficile distinguere tra l'anoressia e l'ossessione ed il digiuno e la preghiera assidua, sicché le tendenze sadomasochiste sono state confuse con lo spirito di sacrificio e così via. D'altro canto, la psicologia, sempre in materia di n., non sempre è stata lineare: fino a non molto tempo fa l'omosessualità era ritenuta una deviazione; molti psicologi ancora oggi faticano a intravedere l'autotrascendenza nella persona umana e gli esempi potrebbero continuare.
Tutto questo ci porta ad affermare che è molto difficile concordare con una definizione univoca di n. e abbiamo bisogno di più approcci, o meglio, di un approccio multidimensionale per poter essere operativi in psicologia della religione. Per l'approccio organicistico puro, la n. è solo o prevalentemente dal punto di vista psicofisiologico, quindi anche la religiosità e l'aggressività possono essere ridotte ad uno squilibrio ormonale o ad una componente genetico-ereditaria. Altrettanto può avvenire per un approccio sociologico: uno squilibrio socio-ambientale è la causa di una n., la cui terapia può avvenire solo con una ristrutturazione dell'ambiente sociale. Gli esempi si possono continuare, ma la conclusione è sempre la stessa: una sola dimensione non può spiegare la complessa realtà umana sia nelle sue varie forme naturali che nelle sue varie forme patologiche. Per questo motivo, anche la religione, da sola, non può spiegare tutto. La prima obiezione che si può rivolgere a questa impostazione è quella del relativismo. In realtà, questo è un rischio reale sia in assoluto che nel caso specifico della differenziazione tra n. e comportamento "normale" nella condotta religiosa. Solo alcuni criteri, sempre opinabili, possono aiutarci ad essere operativi in questo delicatissimo settore.
L'irrazionalità contrapposta alla ragionevolezza. La n. - comunque la si definisca e di qualunque tipologia e intensità - mostra sempre una grande prevalenza della componente irrazionale nella motivazione del comportamento e in particolare nei processi di scelta. Nel comportamento cosiddetto normale, quindi anche nella religiosità "normale", la componente irrazionale non è esclusa; infatti, le emozioni e i sentimenti, pur non facendo parte della sfera logico-razionale, tuttavia devono essere parte integrante, anche se non sempre dominante, del comportamento umano. Nel comportamento psichicamente disturbato potremmo anche osservare una prevalenza della razionalità o un comportamento apparentemente iper-razionale, specie in alcune forme ossessive in una personalità paranoica. Di fatto, anche in questi casi, si ha uno squilibrio che risulta incoerente con la logica razionale.
La struttura psichica equilibrata non è quella che regola il proprio comportamento e le proprie scelte solo sulla base della logica razionale, in questo caso si potrebbe parlare di robot o di computer. L'equilibrio dinamico è quello che prevede un posto altrettanto rilevante anche al contatto, al vissuto e all'espressione di elementi non razionali ma sicuramente ragionevoli: emozioni, sensazioni, sentimenti, umori, intuizioni, percezioni. Tutto ciò che è umano, è ragionevole anche se non è razionale. La prevalenza stabile del solo razionale non fa crescere la persona umana e altrettanto vale per l'irrazionalità. È ragionevole tutto ciò che fa crescere, sia esso razionale che irrazionale: in questo caso sono determinanti la forma e la misura.
Il nevrotico vive in un modo esagerato, quindi sofferente, rallentando o bloccando la propria e altrui crescita, alcune realtà che altri, cosiddetti normali, vivono in modo più ridimensionato, con minore sofferenza e aiutando la propria e altrui crescita.
La psicologia della religione, considerando il comportamento religioso di un mistico o di un qualunque altro fedele, non può fare a meno di porsi di fronte al quesito di una possibile motivazione nevrotica. Più che sorprendersi, è importante comprendere il perché un processo maturativo sia rimasto bloccato o rallentato e il come si possa aiutare una persona o un gruppo a riprendere il proprio percorso di crescita. Il mistico, come chiunque, può essere considerato una persona nevrotica o "normale" nella misura in cui vive la propria razionalità e irrazionalità in modo ragionevole, ossia "in ragione" o "in funzione" del proprio e altrui benessere globale. Questo criterio è valido sia in genere che in particolare per il comportamento religioso.
A. Pacciolla
Bibl. A. Beck, Principi di terapia cognitiva, Roma 1984; R. Bell, La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo ad oggi, Milano 1992; J. Bowlby, L'attaccamento alla madre, Torino 1972; Id., La separazione dalla madre, Torino 1975; R. Carli, s.v., in DES II, 1701-1703; H. Ellemberger, La scoperta dell'inconscio, I, Torino 1976; V.E. Frankl, Logoterapia e analisi esistenziale, Brescia 1977; S.I. Greenberg, La nevrosi: un doloroso stile di vita, Roma 1973; V.F. Guidano - G. Liotti, Elementi di psicoterapia comportamentale, Roma 1979; H.P. Laughlin, Le nevrosi nella pratica clinica, Firenze 1967; D. Meichenbaum, Cognitive Behavior Modification, New York 1977; I.P. Pavlov, Psicopatologia e psichiatria, Roma 1969; D. Shapiro, Stili nevrotici, Roma 1969.
Autore: A. Pacciolla, G. Froggio
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO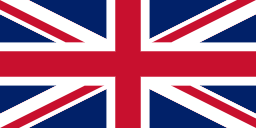 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL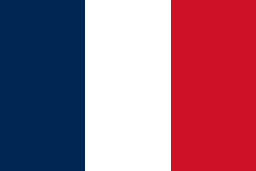 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ