Gnosi
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Il termine e l'origine. Dal greco gnosis, conoscenza. Corrente spirituale e filosofica giunta alla massima fioritura e sistematizzazione nei secc. II-III, che poneva la conoscenza di se stessi, della propria origine e del proprio destino, come strumento supremo di perfezione e di salvezza.
L'origine della g. è individuabile nel sec. I a.C. in un miscuglio sincretistico di fattori propri degli ambienti giudaico, persiano, babilonese ed ellenistico, nei quali per esprimersi assunse terminologia, miti e immagini propri delle culture locali, attingendo anche dalle filosofie platonica e pitagorica. Sembra, però, che la matrice della g. sia per gran parte giudaica, ispirandosi soprattutto al Pentateuco e in modo particolare alla Genesi e a testi apocrifi, soprattutto apocalittici.
II. Alla base della concezione della g. vi è un dualismo cosmico (Dio-materia), morale (bene-male) e antropologico (spirito-corpo). Dio è inconoscibile, trascendente, del tutto estraneo al mondo materiale. Tra lui e la materia è frapposto un mondo intermedio, detto pleroma o ogdoade, abitato dagli eoni: regno luminoso, proprio dello spirito, che deriva da Dio per emanazione e progressivo degradamento.
Il mondo è stato originato da un disordine tra gli eoni e da una contaminazione tra spirito e materia. E opera di un demiurgo, uno degli eoni, di solito identificato con il Dio dell'AT, che ha plasmato la materia. Il mondo, dunque, non è dovuto al Dio supremo ma ad un essere inferiore a lui, perciò è regno di tenebra e di errore, totalmente negativo.
L'uomo è stato plasmato con la terra, ma in lui è presente, anche se nascosto e silente, un elemento spirituale, divino. Accanto e inframmezzo a questi elementi, ve n'è un terzo, quello psichico, che è inferiore allo spirituale. L'uomo si trova nel mondo in una situazione di estraneità e di carcerazione, che nelle fonti viene paragonata allo stato di ubriachezza, di sopore, di oblio, di incoscienza. Vi è quindi, nella g., una concezione pessimistica del mondo e della condizione dell'uomo, ben diversa dalla visione sostanzialmente ottimistica propria della filosofia greca.
L'unico modo che l'uomo ha per redimersi e risollevarsi da questa condizione è quello di liberare dai vincoli della materia la scintilla spirituale che è in lui e che è residuo del mondo superiore, della sua condizione originaria di nobiltà e purezza. Ciò si ottiene con la conoscenza. Questa conoscenza non è da intendersi nel senso di un comune processo cognitivo intellettivo, ma è conoscenza rivelata, o da una persona o da un'entità esterna.
La g. eleva l'uomo liberandolo da questo mondo e dal corpo, entità del tutto esecrabili, annullando le potenze negative e facendo prevalere quelle positive, entrambe presenti in lui, e reintegrandolo così nella sua condizione primigenia, con un processo di rigenerazione, di rinascita in Dio e di ricostituzione della sua essenza originaria, nella luce superiore.
La conoscenza di sé in quanto essere divino, partecipe cioè del mondo spirituale superiore, redime dal male e porta a una unione mistica con Dio, alla pura contemplazione dell'arcana maestà nel regno della luce, oltre che a scandagliare le profondità dell'Essere, il che coincide con la redenzione perfetta.
Al processo cognitivo l'uomo deve unire l' ascesi, un disincarnarsi per raggiungere l'atteggiamento gnostico della propria esistenza che gli permette di conoscere a fondo l'ingannevolezza di questo mondo dei sensi e di sottrarvisi.
Il grado supremo di questa ascesi gnostica è descritto come stato di quiete, di riposo, di estasi e beatitudine, di assenza di passioni, corrisponde alla situazione diametralmente opposta a quella passionalità degli eoni che ha determinato la caduta dello spirito nella materia.
Nel suo procedimento la g. fa uso abbondante del mito, per mezzo del quale spiega l'origine di quel senso di precarietà, angoscia e tentazione che soffre l'uomo; e appaga il suo istintivo desiderio di conoscenza.
La g. e la conseguente redenzione e perfezione sono riservate a pochi, agli uomini spirituali (pneumatikoi), con esclusione di quelli psichici, legati al mondo della psiche (psyche, elemento superiore alla materia ma non divino) e di quelli legati alla terra o ilici (hyle è il nome greco della materia). La g. è superiore alla fede, che è prerogativa della psiche ed è propria degli indotti e comunque non sufficiente a procurare la salvezza, come non lo sono le buone opere.
Sotto il profilo etico, il male non è opera di una volontà libera incline al peccato, ma è un principio metafisico autonomo e sostanziale, insito nella materia e contrapposto allo spirito. Questo sia a livello cosmico, come pure in ogni uomo. E frutto di ignoranza e di errore e vi si rimedia con la g.
Dall'antitesi e dalla scissione spirito-corpo trassero origine due atteggiamenti opposti nei confronti del proprio corpo: da un lato la pratica rigorosa dell'ascetismo, nello sforzo di liberarsi da ogni contaminazione materiale mediante rinunce e penitenze e perfino con l'astensione dal matrimonio; dall'altra una sfrenatezza carnale, dettata dalla persuasione che chi appartiene al mondo dello spirito è immune da ogni malefico influsso della materia.
Vi furono una g. dotta e una g. volgare. Quest'ultima si basava su una mescolanza di pratiche magiche e di credenze astrologiche e mitologiche e si divideva in un gran numero di sette, comunemente designate con la denominazione complessiva di ofiti o adoratori del serpente: è il serpente, infatti, l'essere che nella Genesi si contrappone a Dio, quel Dio cattivo che ha creato questo mondo. La g. dotta era più propensa alla speculazione e fiorì soprattutto in ambiente ellenistico alessandrino.
Bibl. P.T. Camelot - E. Cornelis, Gnose et gnosticisme, in DSAM VI, 508-541; Id., La gnose éternelle, Paris 1961; A.M. Di Nola, Gnosi e gnosticismo, in Aa.Vv. Enciclopedia delle religioni, III, Firenze 1971, 465-493; G. Filoramo, L'attesa della fine. Storia della gnosi, Bari 1983; R.M. Grant, La gnose et les origines chrétiennes, Paris 1964; J. Lanczkowski, s.v., in WMy, 192-194; L. Moraldi (cura di), Testi gnostici, Torino 1982; E. Peterson, Gnosi, Gnosticismo, in EC VI, 876-882; H. Schlier, s.v., in DTI I, 24-37; E.M. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism, a Survey of the Proposed Evidences, Cambridge 1973.
Autore: F. Ruggeri
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO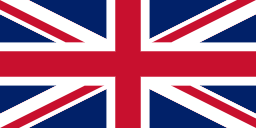 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL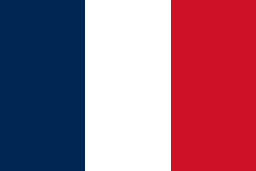 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ