Comunione
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
La comunione eucaristica è uno degli atti in cui il cristiano manifesta l‘originalità della sua fede, la certezza di avere con il Signore un contatto così intimo e reale da trascendere ogni espressione. Questa esperienza ha la sua traduzione nel vocabolario: se il VT non possiede un termine specifico per designarla, la parola greca koinonia esprime nel NT il rapporto del cristiano con il vero Dio rivelato da Gesù, e quello dei cristiani tra loro. La ricerca di una comunione con la divinità non è estranea all‘uomo; la religione, che in lui si esprime come un desiderio di unirsi a Dio, si traduce spesso tramite dei sacrifici o dei pasti sacri, nei quali si ritiene che il dio condivida il cibo (cfr. nutrimento) dei fedeli. D‘altra parte, i pasti di alleanza intendono suggellare tra gli uomini dei legami di fraternità o di amicizia. Se soltanto Gesù Cristo, nostro unico mediatore, è capace di soddisfare questo desiderio, il VT, pur mantenendo gelosamente le distanze invalicabili prima dell‘incarnazione, ne prepara già il compimento.
VT
1. Il culto ebraico riflette il bisogno di entrare in comunione con Dio. Ciò si esprime soprattutto nei sacrifici detti «pacifici», cioè di salute, in cui una parte della vittima torna all‘offerente: mangiandola, questi è ammesso alla mensa di Dio. Perciò molte traduzioni lo chiamano «sacrificio di comunione» (cfr. Lev 3). Di fatto il VT non parla mai esplicitamente di comunione con Dio, ma soltanto di pasti presi «dinanzi a Dio» (Es 18,12; cfr. 24, 11).
2. L’alleanza. - Questo bisogno resterebbe un sogno sterile se Dio non proponesse al suo popolo una forma reale di scambi e di vita comune: con l‘alleanza Jahve assume la responsabilità dell‘esistenza di Israele, ne sposa gli interessi (Es 23, 22), vuole un incontro (Am 3, 2) e cerca di conquistarne il cuore (Os 2,16). Questo disegno di comunione, molla dell‘alleanza, si rivela nell‘apparato di cui Dio circonda la sua iniziativa: i suoi lunghi colloqui con Mosè (Es 19,20-25; 24, 12-18), il nome di «tenda del convegno» dove lo incontra (33,7-11).
3. La legge. - Carta dell‘alleanza, la legge ha per scopo di far conoscere ad Israele le reazioni di Dio (Deut 24,18; Lev 19,2). Obbedire alla legge, lasciarsi plasmare dai suoi precetti, significa quindi trovare Dio ed unirsi a lui (Sal 119); inversamente, amare Dio e cercarlo significa osservare i suoi comandamenti (Deur 10, 12 s).
4. La preghiera. - L‘israelita che vive nella fedeltà all‘alleanza incontra Dio in un modo ancora più intimo, nelle due forme fondamentali della preghiera: nello slancio spontaneo di ammirazione e di gioia dinanzi alle meraviglie divine, che suscita la benedizione, la lode e il ringraziamento; - e nella supplica appassionata alla ricerca della presenza di Dio (Sal 42, 2-5; 63, 2-6), di un incontro che la stessa morte non possa interrompere (Sal 16,9; 49,16; 73, 24).
5. La comunione dei cuori nel popolo è il frutto dell‘alleanza: la solidarietà naturale in seno alla famiglia, al clan, alla tribù, diventa l‘unione di pensiero e di vita al servizio del Dio che raduna Israele. Per essere fedele a questo Dio salvatore l‘ebreo deve considerare il compatriota come suo «fratello» (Deut 22, 1-4; 23, 20) e prodigare la sua sollecitudine ai più diseredati (24, 19 ss). L‘assemblea liturgica delle tradizioni sacerdotali è nello stesso tempo -una comunità nazionale in cammino verso il suo destino divino (cfr. Num.1, 16 ss; 20,6-11; 1 Cron 13, 2), la «comunità di Jahve» e «tutto Israele» (1 Cron 15, 3).
NT
In Cristo la comunione con Dio diventa una realtà; condividendo, nella sua stessa debolezza, la condizione comune a tutti gli uomini (Ebr 2,14), Gesù Cristo concede loro di partecipare alla sua natura divina (2 Piet 1, 4).
1. La comunione col Signore vissuta nella Chiesa. - Fin dall‘inizio della sua vita pubblica Gesù si associa dodici compagni che vuole strettamente partecipi della sua missione di insegnamento e di misericordia (Mc 3,14; 6,7-13). Afferma che i suoi devono condividere le sue sofferenze per essere degni di lui (Mc 8, 34-37 par.; Mt 20, 22; Gv 12, 24 ss; 15,18). Egli è veramente il Messia, il re che fa corpo con il suo popolo. Nello stesso tempo sottolinea l‘unità fondamentale dei due comandamenti dell‘amore (MI 22, 37 ss). L‘unione fraterna dei primi cristiani risulta dalla loro fede comune nel Signore Gesù, dal loro desiderio di imitarlo insieme, dal loro amore per lui, che implica necessariamente il loro amore reciproco: essi avevano «un cuore e un‘anima soli» (Atti 4,32). Questa comunione tra di loro si realizza in primo luogo nella frazione del pane (2,42); nell‘ambito della Chiesa di Gerusalemme, si traduce nella messa in comune dei beni (4, 32 - 5, 11), poi tra comunità originarie del paganesimo e Gerusalemme, nella colletta raccomandata da S. Paolo (2 Cor 8-9; cfr. Rota 12,13). L‘aiuto materiale apportato ai predicatori del vangelo rivela in modo particolare questa comunione conferendole il carattere della gratitudine spirituale (Gal 6, 6; Fil 2, 25). Le persecuzioni sopportate insieme cementano l‘unità dei cuori (2 Cor 1, 7; Ebr 10, 33; 1 Piet 4, 13), così come la partecipazione alla diffusione del vangelo (Fil 1, 5).
2. Significato di questa comunione. a) Per S. Paolo il fedele che aderisce a Cristo mediante la fede ed il battesimo partecipa ai suoi misteri (cfr. i verbi composti con il prefisso syn-). Morto al peccato con Cristo, il cristiano risuscita con lui ad una vita nuova (Rota 6, 3 s; Ef 2, 5 s); le sue sofferenze, la sua stessa morte lo assimilano alla passione, alla morte e alla risurrezione del Signore (2 Cor 4,14; Rom 8,17; Fil 3, 10s; 1 Tess 4,14). La partecipazione al Corpo eucaristico di Cristo (1 Cor 10,16) realizza ad un tempo la «comunione al Figlio» (1, 9) e l‘unione delle membra del corpo (10, 17). Il dono dello Spirito Santo a tutti i cristiani suggella una comunione intima tra loro (2 Cor 13, 13; Fil 2, 1). h) Per S. Giovanni, i discepoli che accolgono l‘annuncio del «Verbo di vita» entrano in comunione con i suoi testimoni (gli apostoli) e, tramite essi, con Gesù e il Padre (1 Gv 1, 3; 2, 24). Infine i cristiani, uniti tra loro, rimangono nell‘amore del Padre e del Figlio, come il Padre e il Figlio sono l‘uno nell‘altro e non fanno che uno (Gv 14, 20; 15,4.7; 17, 20-23; 1 Gv 4,12). La osservanza dei comandamenti di Gesù è il segno autentico del desiderio di questa comunione permanente (Gv 14,21; 15, 10); la realizza la potenza dello Spirito Santo (14,17; 1 Gv 2,27; 3,24; 4,13) e ne è l‘alimento indispensabile il pane eucaristico (Gv 6,56). Così il cristiano gusta in anticipo la gioia eterna, sogno di ogni cuore umano, speranza di Israele: «essere con il Signore, per sempre» (1 Tess 4,17; cfr. Gv 17,24), partecipando alla sua gloria (1 Piet 5,1).
Autore: D. Sesboué e J. Guillet
Fonte: Dizionario di Teologia Biblica
VT
1. Il culto ebraico riflette il bisogno di entrare in comunione con Dio. Ciò si esprime soprattutto nei sacrifici detti «pacifici», cioè di salute, in cui una parte della vittima torna all‘offerente: mangiandola, questi è ammesso alla mensa di Dio. Perciò molte traduzioni lo chiamano «sacrificio di comunione» (cfr. Lev 3). Di fatto il VT non parla mai esplicitamente di comunione con Dio, ma soltanto di pasti presi «dinanzi a Dio» (Es 18,12; cfr. 24, 11).
2. L’alleanza. - Questo bisogno resterebbe un sogno sterile se Dio non proponesse al suo popolo una forma reale di scambi e di vita comune: con l‘alleanza Jahve assume la responsabilità dell‘esistenza di Israele, ne sposa gli interessi (Es 23, 22), vuole un incontro (Am 3, 2) e cerca di conquistarne il cuore (Os 2,16). Questo disegno di comunione, molla dell‘alleanza, si rivela nell‘apparato di cui Dio circonda la sua iniziativa: i suoi lunghi colloqui con Mosè (Es 19,20-25; 24, 12-18), il nome di «tenda del convegno» dove lo incontra (33,7-11).
3. La legge. - Carta dell‘alleanza, la legge ha per scopo di far conoscere ad Israele le reazioni di Dio (Deut 24,18; Lev 19,2). Obbedire alla legge, lasciarsi plasmare dai suoi precetti, significa quindi trovare Dio ed unirsi a lui (Sal 119); inversamente, amare Dio e cercarlo significa osservare i suoi comandamenti (Deur 10, 12 s).
4. La preghiera. - L‘israelita che vive nella fedeltà all‘alleanza incontra Dio in un modo ancora più intimo, nelle due forme fondamentali della preghiera: nello slancio spontaneo di ammirazione e di gioia dinanzi alle meraviglie divine, che suscita la benedizione, la lode e il ringraziamento; - e nella supplica appassionata alla ricerca della presenza di Dio (Sal 42, 2-5; 63, 2-6), di un incontro che la stessa morte non possa interrompere (Sal 16,9; 49,16; 73, 24).
5. La comunione dei cuori nel popolo è il frutto dell‘alleanza: la solidarietà naturale in seno alla famiglia, al clan, alla tribù, diventa l‘unione di pensiero e di vita al servizio del Dio che raduna Israele. Per essere fedele a questo Dio salvatore l‘ebreo deve considerare il compatriota come suo «fratello» (Deut 22, 1-4; 23, 20) e prodigare la sua sollecitudine ai più diseredati (24, 19 ss). L‘assemblea liturgica delle tradizioni sacerdotali è nello stesso tempo -una comunità nazionale in cammino verso il suo destino divino (cfr. Num.1, 16 ss; 20,6-11; 1 Cron 13, 2), la «comunità di Jahve» e «tutto Israele» (1 Cron 15, 3).
NT
In Cristo la comunione con Dio diventa una realtà; condividendo, nella sua stessa debolezza, la condizione comune a tutti gli uomini (Ebr 2,14), Gesù Cristo concede loro di partecipare alla sua natura divina (2 Piet 1, 4).
1. La comunione col Signore vissuta nella Chiesa. - Fin dall‘inizio della sua vita pubblica Gesù si associa dodici compagni che vuole strettamente partecipi della sua missione di insegnamento e di misericordia (Mc 3,14; 6,7-13). Afferma che i suoi devono condividere le sue sofferenze per essere degni di lui (Mc 8, 34-37 par.; Mt 20, 22; Gv 12, 24 ss; 15,18). Egli è veramente il Messia, il re che fa corpo con il suo popolo. Nello stesso tempo sottolinea l‘unità fondamentale dei due comandamenti dell‘amore (MI 22, 37 ss). L‘unione fraterna dei primi cristiani risulta dalla loro fede comune nel Signore Gesù, dal loro desiderio di imitarlo insieme, dal loro amore per lui, che implica necessariamente il loro amore reciproco: essi avevano «un cuore e un‘anima soli» (Atti 4,32). Questa comunione tra di loro si realizza in primo luogo nella frazione del pane (2,42); nell‘ambito della Chiesa di Gerusalemme, si traduce nella messa in comune dei beni (4, 32 - 5, 11), poi tra comunità originarie del paganesimo e Gerusalemme, nella colletta raccomandata da S. Paolo (2 Cor 8-9; cfr. Rota 12,13). L‘aiuto materiale apportato ai predicatori del vangelo rivela in modo particolare questa comunione conferendole il carattere della gratitudine spirituale (Gal 6, 6; Fil 2, 25). Le persecuzioni sopportate insieme cementano l‘unità dei cuori (2 Cor 1, 7; Ebr 10, 33; 1 Piet 4, 13), così come la partecipazione alla diffusione del vangelo (Fil 1, 5).
2. Significato di questa comunione. a) Per S. Paolo il fedele che aderisce a Cristo mediante la fede ed il battesimo partecipa ai suoi misteri (cfr. i verbi composti con il prefisso syn-). Morto al peccato con Cristo, il cristiano risuscita con lui ad una vita nuova (Rota 6, 3 s; Ef 2, 5 s); le sue sofferenze, la sua stessa morte lo assimilano alla passione, alla morte e alla risurrezione del Signore (2 Cor 4,14; Rom 8,17; Fil 3, 10s; 1 Tess 4,14). La partecipazione al Corpo eucaristico di Cristo (1 Cor 10,16) realizza ad un tempo la «comunione al Figlio» (1, 9) e l‘unione delle membra del corpo (10, 17). Il dono dello Spirito Santo a tutti i cristiani suggella una comunione intima tra loro (2 Cor 13, 13; Fil 2, 1). h) Per S. Giovanni, i discepoli che accolgono l‘annuncio del «Verbo di vita» entrano in comunione con i suoi testimoni (gli apostoli) e, tramite essi, con Gesù e il Padre (1 Gv 1, 3; 2, 24). Infine i cristiani, uniti tra loro, rimangono nell‘amore del Padre e del Figlio, come il Padre e il Figlio sono l‘uno nell‘altro e non fanno che uno (Gv 14, 20; 15,4.7; 17, 20-23; 1 Gv 4,12). La osservanza dei comandamenti di Gesù è il segno autentico del desiderio di questa comunione permanente (Gv 14,21; 15, 10); la realizza la potenza dello Spirito Santo (14,17; 1 Gv 2,27; 3,24; 4,13) e ne è l‘alimento indispensabile il pane eucaristico (Gv 6,56). Così il cristiano gusta in anticipo la gioia eterna, sogno di ogni cuore umano, speranza di Israele: «essere con il Signore, per sempre» (1 Tess 4,17; cfr. Gv 17,24), partecipando alla sua gloria (1 Piet 5,1).
Autore: D. Sesboué e J. Guillet
Fonte: Dizionario di Teologia Biblica
 ITALIANO
ITALIANO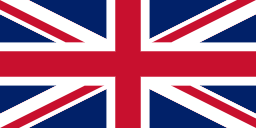 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL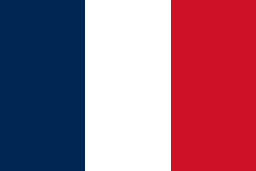 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ