Profetismo
Cerca nella documentazione. Scegli una categoria e compila la form cliccando sul pulsante Cerca.
Leggi la Bibbia. Scegli un versetto utilizzando la form qui sotto.
I. Il concetto. Il p. d'Israele è un fenomeno straordinario ed affascinate nella storia dello jahvismo. La sua storia risale all'XI secolo a.C., cioè alla fine del periodo dei giudici. Infatti, i primi profeti compaiono durante il governo di Samuele, l'ultimo giudice; anzi sotto la sua guida essi formano una comunità dei profeti (cf 1 Sam 10,5s.; 19,18s.). A volte, essi vengono investiti dallo Spirito del Signore e di conseguenza sono presi da un' estasi che può contagiare altre persone che sono vicine a loro. E vero che la storia del p. comincia dall'epoca di Samuele, tuttavia, è notevole che il termine " profeta " venga attribuito già a diversi personaggi che vivono molto prima, per esempio Abramo (cf Gn 20,7), Maria (cf Es 15,20 - profetessa), Aronne (cf Es 7,1) e Mosè il profeta per eccellenza (cf Nm 12,1-8; Dt 18,15-18). Bisogna notare che anche in Nm 11,24s. ci imbattiamo in un'estasi collettiva, una cosa simile a quella raccontata in 1 Sam 10; secondo Nm 11,24ss. i settanta assistenti di Mosè sotto l'influsso dello Spirito del Signore, cominciano a profetare. E vero che i suddetti testi biblici sono anacronistici, ciò nonostante, essi sono utili per la nostra comprensione del p. biblico.
II. Il termine. Il termine " profeta " deriva dal greco profetes (LXX) che è la traduzione del termine ebraico nabi'. Purtroppo, fino ad oggi, gli studiosi non sono d'accordo sulla etimologia di questo termine. Di conseguenza ci sono diversi sensi fondamentali del termine nabi' proposti, per esempio: " Colui che in uno stato di estasi dice tante cose " (dal verbo naba', gorgogliare), o " colui che è posseduto dallo Spirito " (dalla forma passiva del verbo bo', entrare), ecc. La maggioranza degli esperti moderni, però, è dell'opinione che nabi' derivi dal verbo accadico nabu (m) che significa " chiamare o proclamare ". Così un nabi' è " uno che è chiamato da Dio a proclamare la sua parola " (senso passivo) oppure " colui che proclama la Parola di Dio " (senso attivo). Recentemente, D.E. Fleming propone una nuova soluzione: basandosi sull'analisi dei testi siriaci del secondo millennio trovati ad Emar e Mari, propone che il termine ebraico nabi' corrisponda ad un termine siriaco che significa " colui che invoca il nome di Dio ". Ad ogni modo, è chiaro che in ogni interpretazione etimologica del termine nabi' si lasci intravedere un aspetto del p. biblico, anche se non se ne può spiegare in modo esauriente la ricchezza. E problematico anche il rapporto tra nabi' e altri titoli come " uomo di Dio " e " veggente " (in ebr. roèh e hozèh). Questi titoli vengono attribuiti a certi profeti (più antichi): Samuele è un uomo di Dio, un profeta e allo stesso tempo un veggente (cf 1 Sam 9,1s.); Elia è un uomo di Dio (cf 1 Re 17,18.24) e un profeta (cf 1 Re 18,36; 19,10). Gad è un profeta e un veggente (cf 2 Sam 24,11), e così via. Secondo 1 Sam 9,9, " quello che oggi si dice profeta allora si diceva veggente ": ma questa è una semplificazione che non è del tutto soddisfacente.
Il p. non è un fenomeno esclusivo d'Israele. Anche il mondo antico, infatti, conosce molti personaggi corrispondenti ai profeti biblici, per es. hemuneter (" i servi di Dio ") in Egitto, baru in Babilonia, mahhu in Neo-Assiria, ecc. Praticamente essi fungono da veggenti o sacerdoti indovini che pretendono di parlare in nome del loro dio. Da un lato si trovano somiglianze tra il p. israelita e quello presso popoli vicini, ma d'altro canto non mancano anche delle differenze fondamentali tra di loro.
Qui vediamo alcuni elementi fondamentali che costituiscono l'essenza del p. biblico.
III. L'origine divina del p. I profeti cananei e siriaci credono di essere messaggeri di dio. Parlano in nome del loro dio. Ma questa convinzione non è sempre chiara. I profeti biblici, invece, hanno una convinzione irremovibile che sono mandati dal Signore. Ma in che cosa consiste l'essenza del p. biblico? Il testo classico per chiarire l'essenza del p. è Es 6,28-7,2 dove il Signore fa di Aronne il profeta di Mosè; perciò Aronne è la bocca per Mosè, come Mosè e Geremia lo sono per il Signore (cf Es 4,15-16; Ger 15,19). Un vero profeta dice soltanto le parole che il Signore mette sulla sua bocca (cf Dt 18,18; Ger 1,9 ecc.). Tutto ciò che è profetizzato si compie a suo tempo; altrimenti non è un vero profeta (cf Dt 18,21-22). Le formule introduttive, che molto spesso vengono usate dai profeti, sono: " Dice il Signore (Dio d'Israele) " o " la parola del Signore fu rivolta a.... " o " oracolo del Signore ". Inoltre, per sottolineare l'importanza del loro messaggio, a volte, i profeti ci danno l'impressione che la parola di Dio si imponga su di loro senza che riescano a rifiutarla (cf Ger 20,7-9; Am 3,8); ma in realtà il Signore non toglie mai ad un profeta la sua libertà, come nel caso del profeta ribelle, Geremia, a cui il Signore dice: " Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò.... " (Ger 15,19).
IV. Esperienza mistica. E certo che i profeti extrabiblici sono delle persone religiose che hanno dei contatti con la divinità, con un certo culto, in un certo tempio o santuario. Però, questa dimensione religiosa dei profeti ha raggiunto l'espressione più perfetta nei profeti della Bibbia. Questa, infatti, considera i profeti come " servi del Signore " (cf 2 Re 17,13.23; Dn 9,10 ecc.) che proclamano i comandamenti e gli insegnamenti del Signore. Non c'è dubbio che qui il termine " Servo di Dio " è un titolo d'onore per coloro che sono vicini a Dio, che svolgono qualche ruolo nella storia della salvezza, come per esempio Abramo (cf Gn 26,24), Isacco (cf Gn 24,14), Giacobbe (cf Es 32,13), Mosè (cf Es 14,31; Dt 9,11), ecc. I profeti, i servi del Signore, sono amici di Dio. Ne vediamo due esempi. Il primo è Mosè: egli sperimenta un' amicizia molto profonda con il Signore in modo tale che solo con lui il Signore parla " faccia a faccia come un uomo parla con un altro ". Con gli altri profeti, invece, parla attraverso la visione e il sogno (cf Nm 12,6-7; Es 33,11). Il secondo è Elia: egli sta sempre alla presenza del Signore (cf 1 Re 17,1; 18,15); il suo rapporto con Dio è molto stretto, a tal punto che la parola di Dio diventa la sua parola; ciò si può dedurre da 1 Re 17,1, dove Elia dice ad Acab: " Per la vita del Signore... in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io " (letteralmente: " se non per la mia parola "), mentre secondo 1 Re 18,1 è per la parola del Signore che la pioggia sta per cadere. Questa amicizia tra i profeti e il Signore si lascia intravedere anche nelle parole di Amos: " In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servi, i profeti " (Am 3,7). Diversi scrittori parlano di questa amicizia come di un' esperienza mistica, pertanto come nel caso dei mistici, anche i profeti, con gradi diversi, sperimentano l'influenza dello Spirito di Dio che costituisce l'elemento essenziale del p.
Nel loro ruolo di amici di Dio, i profeti possiedono la capacità straordinaria di compiere miracoli, i quali rivelano la loro origine divina. I miracoli, quindi, giustificano la loro esortazione alla conversione (cf Sir 48,15). Come amici di Dio, i profeti fungono da mediatori tra il Signore e il suo popolo; in altre parole, i profeti intercedono per gli israeliti presso Dio (cf 2 Re 19,4; Ger 15,1; ecc.). Probabilmente, è proprio in questa qualità di intercessore, che Abramo viene chiamato profeta (cf Gn 20,7). Infine, come amici di Dio, i profeti hanno la capacità di profetizzare, cioè di predire il futuro.
V. Il contenuto del messaggio profetico. Ciò che distingue i profeti biblici d'Israele da quelli extrabiblici è la loro fede in un solo Dio, quel Dio che ha fatto un' alleanza con loro sul monte Sinai. Questo Dio esige da loro una fedeltà totale, realizzandola nella loro condotta religiosa e morale, che deve essere conforme ai suoi comandamenti, perciò si parla spesso di un " monoteismo etico ". A partire dal libro del Deutero-Isaia, il Signore compare come l'unico Dio di tutta la terra (cf Is 40). Questo monoteismo assoluto, infatti, è dovuto ai profeti-teologi. Sempre in questo contesto si può parlare di una caratteristica del p. biblico che consiste nella interpretazione del futuro. Essi vedono il futuro, sia imminente che lontano, nella luce del Signore che guida la storia del mondo, sia nel passato che nel presente. Si può anche dire, quindi, che l'essenza del p. biblico sta nella teologia della storia di Israele (e del mondo) in virtù del monoteismo o più precisamente dello jahvismo (cf Ger 23,22; Dt 13,2-6). Come dice giustamente P. Gironi: " Non esiste profeta in Israele che non si richiami agli elementi fondamentali della storia del popolo "che Dio pasce": la promessa, l'alleanza, l'elezione, la liberazione, il dono della terra, il dono della discendenza, la speranza nel Messia... ".1
Un vero profeta non parla per piacere agli uomini, come fanno i falsi profeti, ma solo per dire ciò che il Signore gli ispira di dire. A differenza dei profeti stranieri, i profeti biblici richiamano o condannano i re (cf 1 Sam 8,6; 2 Sam 12,1-14; 1 Re 11,29-39; 17,1; Am 7,10s.) e si scagliano contro il culto esteriore, privo di senso spirituale (cf Is 1,10-15; Am 5,21-27). Il p. israelita non esiste in funzione di una politica o di una dinastia come spesso accade in Egitto, ma non mancano i testi che mostrano l'appoggio dei profeti ai re (cf 2 Sam 7,1-17; 24,11; 1 Re 19,15s., ecc.).
In genere, nel NT il termine " profeta " viene adoperato con lo stesso significato che ha nell'AT. Il termine " profeta " viene adoperato sia per i profeti dell'AT che per quelli del NT senza differenza. Così Giovanni Battista è un profeta (cf Lc 1,76; 7,26) come lo è anche Gesù (cf Lc 4,24 par). Gesù è " un profeta potente in opere e parole " (Lc 24,19). Egli è il profeta più perfetto, come si afferma in Eb 1,1: " Dio aveva già parlato... ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente... ha parlato a noi per mezzo del Figlio ". Egli parla solo di cose che ha udito dal Padre (cf Gv 8,26; cf 3,32.34; 5,30; ecc.). Egli vive solamente del Padre (Gv 6,57); anzi, egli e il Padre sono una cosa sola (cf Gv 10,31); questa è un'unione mistica perfetta che nessun essere umano ha mai sperimentato.
In una certa misura tutti i profeti cristiani partecipano del p. di Gesù. Secondo 1 Cor 14, essi profetizzano per edificare, esortare e confermare i cristiani (vv 1-5), per richiamarli alla conversione (v 24); tramite essi Dio rivela i suoi misteri (1 Cor 13,2). Pertanto, il carisma del p. viene posto al secondo posto subito dopo il carisma dell'apostolato (1 Cor 12,28; Ef 3,5; 4,1).
Note: 1 P. Gironi, I libri profetici. Introduzione e note, in La Bibbia: nuovissima versione dei testi originali, Edizioni Paoline, Roma 1983, 1120.
Bibl. Aa.Vv., Prophètisme AT-NT, in DBS VIII, 811-1337; La Bibbia di Gerusalemme, Bologna 1988, 1513-1550 (introduzione ai libri profetici); J. Barton, Oracles of God. Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile, London 1986; M. Buber, La fede dei profeti, Casale Monferrato (AL) 1985; L. Dallière, Le charisme prophètique, in Foi et Vie, 72 (1973), 90-97; P. Gironi, I libri profetici. Introduzioni e note, in La Bibbia: nuovissima versione dei testi originali, Edizioni Paoline, Roma 1983, 1119
1124; K. Koch, The Prophets. I: the Assirian Period, London 1987; B.D. Napier, Prophet, Prophetism, in G.A. Buttrick (ed.), The Interpreter's Dictionary of the Bible, Nashville 1986, 984-1004; G. von Rad, Teologia dell'Antico Testamento, II, Brescia 1974, 22-381; G. Savoca, Profezia, in NDTB, 1232-1247; A.L. Schökel - J.L. Sicre Diaz, I profeti, Roma 1984; B. Vawter, Introduzione alla letteratura profetica, in Aa.Vv., Grande Commentario Biblico, Brescia 1973, 289-306; P. Vallin, s.v., in DSAM XII, 2410-2446; S. Virgulin, I grandi chiamati, Roma 1980.
Autore: H. Pidyarto
Fonte: Dizionario di Mistica (L. Borriello - E. Caruana M.R. Del Genio - N. Suffi)
 ITALIANO
ITALIANO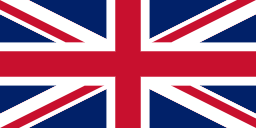 ENGLISH
ENGLISH ESPANOL
ESPANOL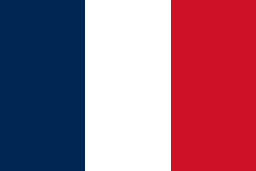 FRANCAIS
FRANCAIS LATINO
LATINO PORTUGUES
PORTUGUES DEUTSCH
DEUTSCH MAGYAR
MAGYAR Ελληνική
Ελληνική לשון עברית
לשון עברית عَرَبيْ
عَرَبيْ